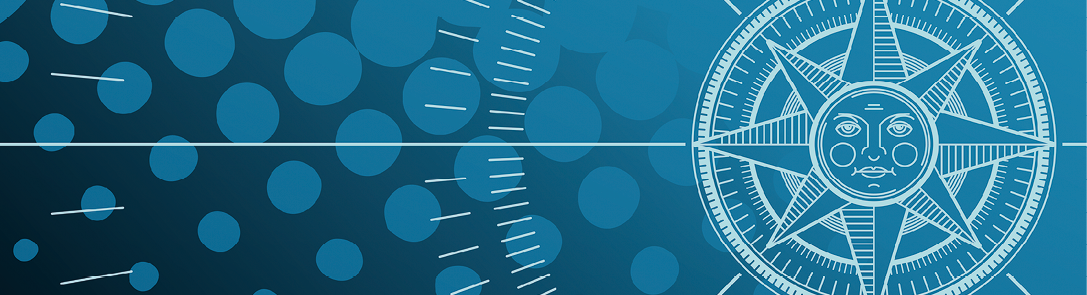
a) La saga dei RAS Qualche hanno fa un nostro editoriale, ancora disponibile in rete1, stigmatizzava l’uso delle analisi per sottogruppi come criterio di approvazione di nuovi farmaci. In particolare, vi si sosteneva che tale analisi fosse essenzialmente esplorativa e che le conclusioni dovessero essere sottoposte ad ulteriori studi programmati ad hoc. Da queste considerazioni nasceva l’esigenza di considerare i risultati di un’analisi per sottogruppi, più che come probativa, semplicemente suggestiva di ipotesi. Quasi tutti gli studi che avevano portato all’approvazione del cetuximab e del panitumumab nel trattamento del carcinoma del colon-retto metastatico, avevano come endpoint primario l’impatto dei due farmaci sulla sopravvivenza libera da progressione (Progression Free Survival, PFS, definita come l’intervallo di tempo che va dall’inizio del trattamento alla progressione di malattia o alla morte del paziente per qualunque causa). I loro risultati, sebbene statisticamente significativi, erano clinicamente poco o per nulla rilevanti. Ad esempio lo studio CRYSTAL, sul cetuximab in prima linea di chemioterapia, mostrava un aumento mediano della PFS di 0,8 mesi (cioè 24 giorni); un altro studio, eseguito con il panitumumab in 3a o 4a linea, evidenziava un aumento di 5 giorni mediani di PFS. Rinviamo i lettori interessati alla discussione degli studi all’editoriale sopra citato. Le analisi per sottogruppi, tutte retrospettive, relative allo stato del gene KRAS (wild type versus mutato) accertato in una percentuale variabile di pazienti nei vari studi (non nell’intero campione), talora ripetute più volte nello stesso studio in base al numero di determinazioni dello stato KRAS al momento disponibili, hanno evidenziato che, nei pazienti KRAS wild type la PFS mediana nei pazienti sottoposti a cetuximab o panitumumab aumentava da 0 a 2 mesi rispetto alla sola chemioterapia (differenze spesso marginali), mentre nei pazienti KRAS mutati la PFS era del tutto simile, se non addirittura peggiore. Sulla base di tali risultati, gli enti regolatori rapidamente mutavano l’approvazione del cetuximab e del panitumumab riservandola ai soli pazienti con KRAS wild type (forse, riducendo l’uso di tali farmaci, volevano far risparmiare il Servizio Sanitario Nazionale!). La rapidità di approvazione in assenza di studi controllati prospettici è stata accolta come un grande progresso dal mondo oncologico probabilmente considerando il “grande impatto” sulla sopravvivenza globale (Overall Survival, OS, definita come l’intervallo di tempo che va dall’inizio del trattamento alla morte del paziente per qualunque causa) del cetuximab e del panitumumab nei pazienti KRAS wild type. Va sottolineato che la sopravvivenza globale non era l’endpoint primario di questi studi, tranne per l’EPIC, in cui peraltro nell’analisi per sottogruppi i pazienti KRAS wild type riportavano una OS inferiore se sottoposti a cetuximab (10,9 vs. 11,6 mesi). Resta comunque difficile da spiegare come nei pazienti con KRAS wild type nello studio CRYSTAL, la OS mediana aumenti da 21,0 mesi a 24,9 mesi (+3,9 mesi) mentre la PFS mediana aumenti solo da 8,7 mesi a 9,9 mesi (+1,2 mesi)2, o come nello studio NCIC-017 la OS aumenti da 4,8 a 9,5 mesi (+4,7 mesi) mentre la PFS aumenti solo da 1,9 a 3,7 mesi (+1,8 mesi)3. Una plausibile spiegazione è che siano state le terapie successive a modificare in qualche modo l’impatto sulla OS, spiegazione che, com’è noto, viene utilizzata per giustificare l’efficacia di un nuovo trattamento quando migliora solo la PFS e non la OS. Per accettare tale interpretazione, però, occorre ritenere che i pazienti che hanno ricevuto i “nuovi farmaci” siano più predisposti degli altri a trarre beneficio dalle successive linee di terapia, cosa difficile da credere, anche perché non sappiamo di quali terapie si tratta. Comunque, nella ricerca scientifica, la spiegazione di un fenomeno non può essere un atto di fede e, quindi, va sottoposta ad una valutazione empirica mediante studi programmati ad hoc; nel nostro caso, ad esempio, sarebbe sufficiente standardizzare le successive linee di terapia. Pertanto, sospendiamo il giudizio e vediamo quali sono le reali novità. La prima novità è che finalmente due studi prospettici di fase III hanno valutato l’efficacia del cetuximab in pazienti KRAS wild type con carcinoma colo-rettale in associazione alla chemioterapia rispetto alla chemioterapia da sola in prima linea di trattamento ed i risultati sono purtroppo negativi. Il primo studio (MCR COIN trial), eseguito in Inghilterra, Irlanda e Belgio, ha valutato 715 pazienti, tutti con carcinoma KRAS wild type (243 sottoposti a oxaliplatino +5 - fluorouracile in infusione continua e 472 a oxaliplatino+capecitabina), randomizzati alla sola chemioterapia o alla chemioterapia con aggiunta del cetuximab. La OS mediana, endpoint primario, non era significativamente differente fra i due trattamenti (17,0 mesi con cetuximab vs. 17,9 mesi con sola chemioterapia), così come la PFS mediana che era addirittura uguale (8,6 vs. 8,6 mesi)4. La percentuale di risposte era superiore nel braccio che riceveva cetuximab (64% vs. 57%). Il secondo studio condotto in Scandinavia (NORDIC-VII) ha arruolato 324 pazienti (194 pazienti KRAS wild type e 130 pazienti KRAS mutati) trattati con boli di acido folinico e fluorouracile+oxaliplatino ± cetuximab. I risultati, tutti non significativamente differenti, hanno mostrato nei pazienti KRAS wild type una PFS mediana (endpoint primario dello studio) di 7,9 mesi con cetuximab vs. 8,7 mesi senza cetuximab, e una OS mediana di 20,1 mesi vs. 22,0 mesi rispettivamente. Al contrario si evidenziava un trend positivo a favore del cetuximab nei pazienti con KRAS mutato: PFS 9,2 vs. 7,8 mesi, OS 21,1 vs. 20,4 mesi5. Tutto chiaro? I risultati negativi dei due studi hanno scatenato una ridda di ipotesi in grado di spiegarli. Non sarà che il cetuximab non funziona in prima linea quando associato a oxaliplatino, mentre funziona quando associato a irinotecan? È difficile accogliere tale spiegazione; infatti dovremmo smentire tutti i fantastici risultati ottenuti negli studi con cetuximab o panitumumab associati a oxaliplatino in prima linea di chemioterapia (OPUS, PRIME) ed i dati preclinici che dimostrano un sinergismo fra i due farmaci. Allora, ricorrendo ancora alle analisi per sottogruppi, si evince, nello studio COIN, che il cetuximab funziona solo con il fluorouracile in infusione continua ma non con la capecitabina. Non solo, ma probabilmente il cetuximab non funziona neanche con i boli di fluorouracile come dimostra lo studio NORDIC-VII. Ovviamente, non c’è nessuno a sostenere che queste ipotesi andrebbero testate in studi ad hoc prospettici e controllati. Il massimo del parossismo si raggiunge quando si vuole spiegare un risultato negativo affermando che la mancata differenza in sopravvivenza possa essere dovuta ai diversi trattamenti ricevuti dai pazienti dello studio COIN e NORDIC-VII nelle linee di chemioterapia successive alla prima (un numero rilevante di pazienti nel braccio di controllo dello studio COIN ha ricevuto più linee di trattamento successive alla prima e un numero importante di pazienti nel braccio di controllo dello studio NORDIC-VII ha ricevuto cetuximab nelle linee successive)6. In ultima analisi, il messaggio che si è tentato di far passare è che i risultati delle analisi per sottogruppi hanno più valore di quelli degli studi prospettici randomizzati. Recentemente altre mutazioni del gene RAS (oltre la mutazione del KRAS esone 2 che finora aveva escluso l’uso di cetuximab e panitumumab nella pratica clinica) sembrano avere un effetto predittivo negativo sull’efficacia degli inibitori dell’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). Rianalizzando i dati dello studio PRIME (FOLFOX4+panitumumab versus FOLFOX4 da solo)7 è stata fatta un’analisi per sottogruppi includendo anche le mutazioni del KRAS 3 o 4, NRAS 2, 3 o 4 ed anche BRAF 15)8. Com’è ormai prassi routinaria, si tende sempre più ad allontanare la ricerca clinica dai canoni della ricerca scientifica: il fatto che tali dati erano già stati analizzati non ha comportato alcun aggiustamento dei livelli di significatività statistica in accordo alla disuguaglianza di Bonferroni. Questo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha valutato 512 pazienti senza mutazioni RAS; l’incidenza di mutazioni aggiuntive di RAS, nella popolazione con KRAS esone 2 non mutato, era del 17%: circa un paziente su 6, tra quelli considerati wild type, erano erroneamente considerati tali perché, in realtà, una mutazione del gene RAS l’avevano, sebbene differente da quella relativa all’esone 2. I pazienti RAS “veri” wild type che erano trattati con panitumumab+FOLFOX4 presentavano una PFS mediana e una OS mediana entrambe significativamente superiori rispetto a coloro che erano trattati con solo FOLFOX4 (rispettivamente, 10,1 vs. 7,9 mesi e 26,0 vs. 20,2 mesi). Inoltre, cosa ancora più impressionante, pazienti sottoposti a panitumumab senza mutazioni RAS e BRAF (446 pazienti) presentavano un vantaggio nella OS mediana che aumentava di 7,4 mesi (da 20,9 mesi a 28,3 mesi) rispetto a chi riceveva solo FOLFOX48. Invece le mutazioni BRAF da sole avevano solo un valore prognostico negativo, qualunque fosse stato il trattamento ricevuto. Un’analisi dei risultati osservati sui pazienti dello studio di confronto tra panitumumab versus best supportive care in 3° o 4° linea di chemioterapia, condotta con le stesse modalità, mostrava risultati simili. Per non rimanere indietro nella saga dei RAS, anche il cetuximab è stato valutato in rapporto alle mutazioni RAS, utilizzando i dati dello studio OPUS che confrontava cetuximab+FOLFOX4 versus FOLFOX4 da solo in prima linea di chemioterapia in 337 pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico; di questi 179 pazienti non avevano mutazioni RAS9. L’incidenza di mutazioni aggiuntive di RAS nella popolazione con KRAS esone 2 non mutato era del 30,5%. La PFS mediana era aumentata da 5,8 mesi a 12,0 mesi mentre la OS mediana passava da 17,8 a 20,7 mesi, differenza quest’ultima non significativa. Va segnalato inoltre che, negli studi riportati, i pazienti con mutazioni RAS trattati con panitumumab o cetuximab associati alla chemioterapia presentavano una OS e una PFS mediane inferiori rispetto a quelli che ricevevano la sola chemioterapia. Sulla base di queste ricerche gli enti regolatori hanno rapidamente modificato l’indicazione autorizzativa per i due farmaci, escludendo dal loro uso tutti i pazienti con mutazioni KRAS o NRAS. Come sopra osservato, ciò ridurrà ulteriormente il numero di pazienti eleggibili al trattamento diminuendo così la spesa per queste terapie. D’altra parte, ci sono stati ritardi incredibili nell’esecuzione di tali analisi che di fatto avrebbero risparmiato terapie più tossiche e meno efficaci a tanti pazienti se fossero state eseguite prima. Va considerato, infatti, che, essendo già da anni noto il razionale degli studi recentemente pubblicati, così come erano già disponibili i dati, per salvaguardare i pazienti sarebbe stato sufficiente eseguire elaborazioni appropriate e tempestive, com’è stato denunciato recentemente su Lancet Oncology10.
Quasi tutti gli studi che avevano portato all’approvazione del cetuximab e del panitumumab nel trattamento del carcinoma del colon-retto metastatico, avevano come endpoint primario l’impatto dei due farmaci sulla sopravvivenza libera da progressione (Progression Free Survival, PFS, definita come l’intervallo di tempo che va dall’inizio del trattamento alla progressione di malattia o alla morte del paziente per qualunque causa). I loro risultati, sebbene statisticamente significativi, erano clinicamente poco o per nulla rilevanti. Ad esempio lo studio CRYSTAL, sul cetuximab in prima linea di chemioterapia, mostrava un aumento mediano della PFS di 0,8 mesi (cioè 24 giorni); un altro studio, eseguito con il panitumumab in 3a o 4a linea, evidenziava un aumento di 5 giorni mediani di PFS. Rinviamo i lettori interessati alla discussione degli studi all’editoriale sopra citato. Le analisi per sottogruppi, tutte retrospettive, relative allo stato del gene KRAS (wild type versus mutato) accertato in una percentuale variabile di pazienti nei vari studi (non nell’intero campione), talora ripetute più volte nello stesso studio in base al numero di determinazioni dello stato KRAS al momento disponibili, hanno evidenziato che, nei pazienti KRAS wild type la PFS mediana nei pazienti sottoposti a cetuximab o panitumumab aumentava da 0 a 2 mesi rispetto alla sola chemioterapia (differenze spesso marginali), mentre nei pazienti KRAS mutati la PFS era del tutto simile, se non addirittura peggiore. Sulla base di tali risultati, gli enti regolatori rapidamente mutavano l’approvazione del cetuximab e del panitumumab riservandola ai soli pazienti con KRAS wild type (forse, riducendo l’uso di tali farmaci, volevano far risparmiare il Servizio Sanitario Nazionale!). La rapidità di approvazione in assenza di studi controllati prospettici è stata accolta come un grande progresso dal mondo oncologico probabilmente considerando il “grande impatto” sulla sopravvivenza globale (Overall Survival, OS, definita come l’intervallo di tempo che va dall’inizio del trattamento alla morte del paziente per qualunque causa) del cetuximab e del panitumumab nei pazienti KRAS wild type. Va sottolineato che la sopravvivenza globale non era l’endpoint primario di questi studi, tranne per l’EPIC, in cui peraltro nell’analisi per sottogruppi i pazienti KRAS wild type riportavano una OS inferiore se sottoposti a cetuximab (10,9 vs. 11,6 mesi). Resta comunque difficile da spiegare come nei pazienti con KRAS wild type nello studio CRYSTAL, la OS mediana aumenti da 21,0 mesi a 24,9 mesi (+3,9 mesi) mentre la PFS mediana aumenti solo da 8,7 mesi a 9,9 mesi (+1,2 mesi)2, o come nello studio NCIC-017 la OS aumenti da 4,8 a 9,5 mesi (+4,7 mesi) mentre la PFS aumenti solo da 1,9 a 3,7 mesi (+1,8 mesi)3. Una plausibile spiegazione è che siano state le terapie successive a modificare in qualche modo l’impatto sulla OS, spiegazione che, com’è noto, viene utilizzata per giustificare l’efficacia di un nuovo trattamento quando migliora solo la PFS e non la OS. Per accettare tale interpretazione, però, occorre ritenere che i pazienti che hanno ricevuto i “nuovi farmaci” siano più predisposti degli altri a trarre beneficio dalle successive linee di terapia, cosa difficile da credere, anche perché non sappiamo di quali terapie si tratta. Comunque, nella ricerca scientifica, la spiegazione di un fenomeno non può essere un atto di fede e, quindi, va sottoposta ad una valutazione empirica mediante studi programmati ad hoc; nel nostro caso, ad esempio, sarebbe sufficiente standardizzare le successive linee di terapia. Pertanto, sospendiamo il giudizio e vediamo quali sono le reali novità. La prima novità è che finalmente due studi prospettici di fase III hanno valutato l’efficacia del cetuximab in pazienti KRAS wild type con carcinoma colo-rettale in associazione alla chemioterapia rispetto alla chemioterapia da sola in prima linea di trattamento ed i risultati sono purtroppo negativi. Il primo studio (MCR COIN trial), eseguito in Inghilterra, Irlanda e Belgio, ha valutato 715 pazienti, tutti con carcinoma KRAS wild type (243 sottoposti a oxaliplatino +5 - fluorouracile in infusione continua e 472 a oxaliplatino+capecitabina), randomizzati alla sola chemioterapia o alla chemioterapia con aggiunta del cetuximab. La OS mediana, endpoint primario, non era significativamente differente fra i due trattamenti (17,0 mesi con cetuximab vs. 17,9 mesi con sola chemioterapia), così come la PFS mediana che era addirittura uguale (8,6 vs. 8,6 mesi)4. La percentuale di risposte era superiore nel braccio che riceveva cetuximab (64% vs. 57%). Il secondo studio condotto in Scandinavia (NORDIC-VII) ha arruolato 324 pazienti (194 pazienti KRAS wild type e 130 pazienti KRAS mutati) trattati con boli di acido folinico e fluorouracile+oxaliplatino ± cetuximab. I risultati, tutti non significativamente differenti, hanno mostrato nei pazienti KRAS wild type una PFS mediana (endpoint primario dello studio) di 7,9 mesi con cetuximab vs. 8,7 mesi senza cetuximab, e una OS mediana di 20,1 mesi vs. 22,0 mesi rispettivamente. Al contrario si evidenziava un trend positivo a favore del cetuximab nei pazienti con KRAS mutato: PFS 9,2 vs. 7,8 mesi, OS 21,1 vs. 20,4 mesi5. Tutto chiaro? I risultati negativi dei due studi hanno scatenato una ridda di ipotesi in grado di spiegarli. Non sarà che il cetuximab non funziona in prima linea quando associato a oxaliplatino, mentre funziona quando associato a irinotecan? È difficile accogliere tale spiegazione; infatti dovremmo smentire tutti i fantastici risultati ottenuti negli studi con cetuximab o panitumumab associati a oxaliplatino in prima linea di chemioterapia (OPUS, PRIME) ed i dati preclinici che dimostrano un sinergismo fra i due farmaci. Allora, ricorrendo ancora alle analisi per sottogruppi, si evince, nello studio COIN, che il cetuximab funziona solo con il fluorouracile in infusione continua ma non con la capecitabina. Non solo, ma probabilmente il cetuximab non funziona neanche con i boli di fluorouracile come dimostra lo studio NORDIC-VII. Ovviamente, non c’è nessuno a sostenere che queste ipotesi andrebbero testate in studi ad hoc prospettici e controllati. Il massimo del parossismo si raggiunge quando si vuole spiegare un risultato negativo affermando che la mancata differenza in sopravvivenza possa essere dovuta ai diversi trattamenti ricevuti dai pazienti dello studio COIN e NORDIC-VII nelle linee di chemioterapia successive alla prima (un numero rilevante di pazienti nel braccio di controllo dello studio COIN ha ricevuto più linee di trattamento successive alla prima e un numero importante di pazienti nel braccio di controllo dello studio NORDIC-VII ha ricevuto cetuximab nelle linee successive)6. In ultima analisi, il messaggio che si è tentato di far passare è che i risultati delle analisi per sottogruppi hanno più valore di quelli degli studi prospettici randomizzati. Recentemente altre mutazioni del gene RAS (oltre la mutazione del KRAS esone 2 che finora aveva escluso l’uso di cetuximab e panitumumab nella pratica clinica) sembrano avere un effetto predittivo negativo sull’efficacia degli inibitori dell’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). Rianalizzando i dati dello studio PRIME (FOLFOX4+panitumumab versus FOLFOX4 da solo)7 è stata fatta un’analisi per sottogruppi includendo anche le mutazioni del KRAS 3 o 4, NRAS 2, 3 o 4 ed anche BRAF 15)8. Com’è ormai prassi routinaria, si tende sempre più ad allontanare la ricerca clinica dai canoni della ricerca scientifica: il fatto che tali dati erano già stati analizzati non ha comportato alcun aggiustamento dei livelli di significatività statistica in accordo alla disuguaglianza di Bonferroni. Questo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha valutato 512 pazienti senza mutazioni RAS; l’incidenza di mutazioni aggiuntive di RAS, nella popolazione con KRAS esone 2 non mutato, era del 17%: circa un paziente su 6, tra quelli considerati wild type, erano erroneamente considerati tali perché, in realtà, una mutazione del gene RAS l’avevano, sebbene differente da quella relativa all’esone 2. I pazienti RAS “veri” wild type che erano trattati con panitumumab+FOLFOX4 presentavano una PFS mediana e una OS mediana entrambe significativamente superiori rispetto a coloro che erano trattati con solo FOLFOX4 (rispettivamente, 10,1 vs. 7,9 mesi e 26,0 vs. 20,2 mesi). Inoltre, cosa ancora più impressionante, pazienti sottoposti a panitumumab senza mutazioni RAS e BRAF (446 pazienti) presentavano un vantaggio nella OS mediana che aumentava di 7,4 mesi (da 20,9 mesi a 28,3 mesi) rispetto a chi riceveva solo FOLFOX48. Invece le mutazioni BRAF da sole avevano solo un valore prognostico negativo, qualunque fosse stato il trattamento ricevuto. Un’analisi dei risultati osservati sui pazienti dello studio di confronto tra panitumumab versus best supportive care in 3° o 4° linea di chemioterapia, condotta con le stesse modalità, mostrava risultati simili. Per non rimanere indietro nella saga dei RAS, anche il cetuximab è stato valutato in rapporto alle mutazioni RAS, utilizzando i dati dello studio OPUS che confrontava cetuximab+FOLFOX4 versus FOLFOX4 da solo in prima linea di chemioterapia in 337 pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico; di questi 179 pazienti non avevano mutazioni RAS9. L’incidenza di mutazioni aggiuntive di RAS nella popolazione con KRAS esone 2 non mutato era del 30,5%. La PFS mediana era aumentata da 5,8 mesi a 12,0 mesi mentre la OS mediana passava da 17,8 a 20,7 mesi, differenza quest’ultima non significativa. Va segnalato inoltre che, negli studi riportati, i pazienti con mutazioni RAS trattati con panitumumab o cetuximab associati alla chemioterapia presentavano una OS e una PFS mediane inferiori rispetto a quelli che ricevevano la sola chemioterapia. Sulla base di queste ricerche gli enti regolatori hanno rapidamente modificato l’indicazione autorizzativa per i due farmaci, escludendo dal loro uso tutti i pazienti con mutazioni KRAS o NRAS. Come sopra osservato, ciò ridurrà ulteriormente il numero di pazienti eleggibili al trattamento diminuendo così la spesa per queste terapie. D’altra parte, ci sono stati ritardi incredibili nell’esecuzione di tali analisi che di fatto avrebbero risparmiato terapie più tossiche e meno efficaci a tanti pazienti se fossero state eseguite prima. Va considerato, infatti, che, essendo già da anni noto il razionale degli studi recentemente pubblicati, così come erano già disponibili i dati, per salvaguardare i pazienti sarebbe stato sufficiente eseguire elaborazioni appropriate e tempestive, com’è stato denunciato recentemente su Lancet Oncology10.
b) Differenze tra Cetuximab e Bevacizumab
È un tema importante, ma non ancora chiarito. Recentemente sono stati resi noti i risultati dello studio FIRE-3, realizzato anche con il supporto della casa farmaceutica produttrice del cetuximab, il primo studio randomizzato di fase III di confronto tra bevacizumab e cetuximab ambedue associati a FOLFIRI11. L’endpoint primario di questo studio era, stranamente (ma non tanto, a ben riflettere), la percentuale di risposte ottenute in prima linea di chemioterapia. La popolazione da arruolare nello studio è stata calcolata considerando una differenza del 12% di risposte a favore del cetuximab (dal 50% con il bevacizumab al 62% con il cetuximab). Lo studio, eseguito in 592 pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico KRAS wild type, ha dimostrato una simile attività dei due trattamenti (percentuali di risposte nel 62% con cetuximab e 57% con bevacizumab). Anche la PFS, endpoint secondario, era simile (10,0 vs. 10,3 mesi). Però, la OS mediana era maggiore nei pazienti trattati con cetuximab (28,7 vs. 25,0 mesi). Come al solito, vengono strombazzati risultati a favore del cetuximab, che, invece, sarebbero da investigare ulteriormente con studi ad hoc sull’effetto dei trattamenti eseguiti nelle successive linee di chemioterapia. Nel nostro caso, ciò è particolarmente importante considerando che le curve cominciano a separarsi dopo 18-24 mesi dall’inizio della terapia e, quindi, dopo molto tempo dalla progressione della malattia con la conseguente sospensione del cetuximab o del bevacizumab. Al convegno ECCO 2013, tenutosi ad Amsterdam, sono stati presentati i risultati ottenuti con i due trattamenti nei pazienti KRAS wild type (un sottogruppo dei pazienti arruolati nello studio perché solo in 396/592 era possibile avere il materiale per la determinazione dello stato KRAS e NRAS)12. In questo sottocollettivo di pazienti la percentuale di risposte (76% vs. 65,2%) e la OS (33,1 vs. 25,9 mesi) erano entrambe significativamente superiori nei pazienti trattati con cetuximab, mentre la PFS era praticamente uguale (10,5 vs. 10,4 mesi). Per capire veramente se vi sono differenze tra i due trattamenti è necessario attendere i risultati di uno studio intergruppo che arruolerà 1200 pazienti (CALGB 80405, NCT00265850) e che avrà come endpoint primario la OS.
Lo studio, eseguito in 592 pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico KRAS wild type, ha dimostrato una simile attività dei due trattamenti (percentuali di risposte nel 62% con cetuximab e 57% con bevacizumab). Anche la PFS, endpoint secondario, era simile (10,0 vs. 10,3 mesi). Però, la OS mediana era maggiore nei pazienti trattati con cetuximab (28,7 vs. 25,0 mesi). Come al solito, vengono strombazzati risultati a favore del cetuximab, che, invece, sarebbero da investigare ulteriormente con studi ad hoc sull’effetto dei trattamenti eseguiti nelle successive linee di chemioterapia. Nel nostro caso, ciò è particolarmente importante considerando che le curve cominciano a separarsi dopo 18-24 mesi dall’inizio della terapia e, quindi, dopo molto tempo dalla progressione della malattia con la conseguente sospensione del cetuximab o del bevacizumab. Al convegno ECCO 2013, tenutosi ad Amsterdam, sono stati presentati i risultati ottenuti con i due trattamenti nei pazienti KRAS wild type (un sottogruppo dei pazienti arruolati nello studio perché solo in 396/592 era possibile avere il materiale per la determinazione dello stato KRAS e NRAS)12. In questo sottocollettivo di pazienti la percentuale di risposte (76% vs. 65,2%) e la OS (33,1 vs. 25,9 mesi) erano entrambe significativamente superiori nei pazienti trattati con cetuximab, mentre la PFS era praticamente uguale (10,5 vs. 10,4 mesi). Per capire veramente se vi sono differenze tra i due trattamenti è necessario attendere i risultati di uno studio intergruppo che arruolerà 1200 pazienti (CALGB 80405, NCT00265850) e che avrà come endpoint primario la OS.
c) Aflibercept come 2a linea di chemioterapia
L’aflibercept, un inibitore del VEGF, è stato approvato per pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico, in progressione dopo un regime a base di oxaliplatino, in combinazione con irinotecan, acido folinico e fluorouracile (FOLFIRI). Il farmaco è somministrato a dosi di 4mg/m2 ogni 14 giorni, seguito da FOLFIRI. L’aflibercept è stato valutato in un solo studio clinico randomizzato doppio cieco versus placebo, in cui i pazienti ricevevano FOLFIRI da solo o in associazione con aflibercept. L’endpoint primario dello studio era la OS ed è stato calcolato un campione di 1200 pazienti per dimostrare una riduzione del rischio di morte (Hazard Ratio, HR) del 20%13. I pazienti potevano o meno aver assunto precedentemente bevacizumab (nello studio circa il 30% dei pazienti era già stato trattato con tale farmaco). Sono stati arruolati 1226 pazienti, 614 trattati con aflibercept più FOLFIRI e 612 con solo FOLFIRI. I pazienti trattati con aflibercept presentavano una OS significativamente superiore (13,5 mesi vs. 12,1 mesi, con una riduzione dell’HR del 18,3%). Anche la PFS era significativamente superiore (6,9 mesi vs. 4,7 mesi), così come la percentuale di risposte (19,8% vs. 11,1%). La tossicità era importante: quella di grado 3 o 4 è stata osservata nell’83,5% dei pazienti trattati con aflibercept e nel 62,5% nel gruppo di controllo. Più precisamente, le tossicità di grado 3 o 4 più importanti erano rappresentate da ipertensione (19,3% vs. 1,5%), emorragie (2,9% vs. 1,7%), eventi tromboembolici arteriosi (1,8% vs. 0,5%) e venosi (7,9% vs. 6,3%), proteinuria (7,9% vs. 1,2%). Alcuni effetti collaterali tipici della chemioterapia erano altresì significativamente più frequenti nel braccio di pazienti sottoposti ad aflibercept: diarrea (19,3% vs. 7,8%), astenia (16,9% vs. 10,6%), stomatite (13,7% vs. 5,0%), infezioni (12,3% vs. 6,9%) ed eritrodisestesia palmoplantare (2,8% vs. 0,5%). I pazienti che ricevevano aflibercept hanno più spesso degli altri interrotto il trattamento (26,8% vs. 12,1%). Purtroppo lo studio non ha valutato l’impatto del trattamento sulla qualità di vita dei pazienti. La prima osservazione da fare è che il beneficio dell’associazione dell’aflibercept alla chemioterapia di seconda linea con irinotecan rispetto alla sola chemioterapia è veramente marginale (OS mediana +1,4 mesi). Infatti, l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) ha costituito un working group, il Clinically Meaningful Outcomes Working Groups (ASCO CMOWG) che, in una “draft recommendation” per 4 neoplasie metastatiche (colon-retto, polmone, pancreas e mammella), ha convenuto di definire come obiettivo clinicamente rilevante per futuri studi clinici un aumento della OS mediana di 3-5 mesi.Infine, va considerato che uno studio di fase III, condotto su 820 pazienti in progressione dopo una chemioterapia di prima linea con bevacizumab, volto a valutare l’efficacia del bevacizumab associato a chemioterapia di seconda linea rispetto alla sola chemioterapia, ha dimostrato un aumento della OS simile a quella dello studio dell’aflibercept e superiore rispetto al braccio trattato con sola chemioterapia (11,2 vs. 9,8 mesi). Altresì aumentata era anche la PFS (5,7 vs. 4,1 mesi)14. Inoltre, la tossicità del bevacizumab, che sembra meno tossico dell’aflibercept (ma mancano studi di confronto), era risultata simile a quella riscontrata nel braccio di controllo, sebbene si fossero verificati più spesso sanguinamenti (2% vs. 1%), eventi tromboembolici venosi (5% vs. 3%) e perforazioni gastrointestinali (2% vs. 1,5%).
d) Regorafenib in pazienti già trattati con la chemioterapia disponibile
Il regorafenib è un altro inibitore del VEGF che è stato approvato per pazienti con carcinoma del colon - retto metastatico che sono già stati trattati con le chemioterapie disponibili, o che non sono candidati a riceverle, includendo in tali terapie quelle a base di fluoropirimidine, altri inibitori del VEGF e dell’EGFR. Il farmaco viene somministrato a dosi di 160mg die per os per tre settimane sì ed una settimana no. Il regorafenib è stato valutato in uno studio in doppio cieco controllato con placebo in 760 pazienti, randomizzati 2:1 entro 3 mesi dalla progressione dopo qualsiasi precedente chemioterapia. Tutti i pazienti erano stati trattati in precedenza con bevacizumab: 505 ricevettero regorafenib e 255 placebo15. L’endpoint primario era la OS. La OS era risultata significativamente superiore con il regorafenib (6,4 vs. 5,0 mesi) evidenziando una riduzione del rischio di morte (HR) del 23% rispetto al placebo. La PFS mediana era di 1,9 mesi con regorafenib vs. 1,7 mesi con placebo. La percentuale di risposte era rispettivamente dell’1,0% e dello 0,4%. Gli eventi avversi erano significativamente più frequenti con il regorafenib (grado 3 o 4 nel 54% vs. il 14% dei pazienti) e portarono ad interrompere il trattamento nel 61% vs. il 22% dei pazienti. Gli eventi avversi di grado 3 o 4 del regorafenib più comuni sono stati: sindrome mani-piedi (17% dei pazienti), fatigue (10%), diarrea (7%), ipertensione (7%) e rash cutaneo (6%). Il deterioramento della qualità di vita, valutata con il questionario EORTC QLQ-C30, era simile nei due bracci di trattamento. Il farmaco presenta una maggiore ma marginale efficacia (+1,4 mesi di OS) con importante tossicità e, anche in questo caso, è difficile capire come esso riesca dopo la sua sospensione a migliorare significativamente la OS, dato che non determina un aumento significativo della PFS.
Carcinoma del pancreas metastatico
Il paclitaxel-albumina (Abraxane), in combinazione con gemcitabina, è stato approvato dall’EMA per il trattamento di prima linea dell’adenocarcinoma pancreatico localmente avanzato inoperabile o metastatico. Lo studio registrativo è uno studio randomizzato che ha confrontato in 861 pazienti con carcinoma del pancreas avanzato la combinazione di abraxane con gemcitabina versus gemcitabina da sola16. L’endpoint primario dello studio era la OS. L’Abraxane è stato somministrato alla dose di 125mg/m2 nei giorni 1, 8, 15 ogni 4 settimane, la gemcitabina 1000 mg/m2 per 7 settimane nel 1° ciclo di 8 settimane, e poi nei giorni 1, 8, 15 ogni 4 settimane. La OS mediana con la combinazione è aumentata da 6,7 mesi a 8,5 mesi (+1,8 mesi). L’ASCO Clinically Meaningful Outcomes Working Groups ritiene clinicamente rilevante in questi pazienti un aumento della OS mediana di 4-5 mesi (di 3-4 mesi se il trattamento ha una limitata tossicità come nel caso della gemcitabina). Con la combinazione, la PFS mediana è aumentata da 3,7 a 5,5 mesi e la percentuale di risposte dal 7% al 23%. La tossicità di grado 3 o 4 era superiore con la combinazione (fatigue 17% vs. 7%, neuropatia periferica 17% vs. 1%, neutropenia 38% vs. 27%, leucopenia 31% vs. 16%). Pertanto la combinazione di Abraxane più gemcitabina dimostra una maggior efficacia, statisticamente significativa, ma da un punto di vista clinico moderatamente importante rispetto alla sola gemcitabina e, inoltre, com’era da attendersi, la combinazione aumenta la tossicità del trattamento. Purtroppo in questo studio non è stato valutato l’impatto dei trattamenti sulla qualità di vita che nel carcinoma del pancreas, a nostro avviso, diversamente da quanto giudicato dall’ASCO Clinically Meaningful Outcomes Working Groups, è un endpoint importante quanto la OS. Inoltre, vi sono obiezioni anche sulla scelta del comparator, in quanto si sarebbe dovuto confrontare la combinazione di gemcitabina e abraxane con il FOLFIRINOX, che finora è stato considerato il regime terapeutico più efficace nel carcinoma pancreatico avanzato. Infatti, uno studio randomizzato di fase II-III vs. gemcitabina ha dimostrato che FOLFIRINOX determina un aumento della OS mediana statisticamente significativo e clinicamente rilevante (11,1 mesi vs. 6,8 mesi, +4,3 mesi, riduzione dell’HR di morte del 47%)17. Anche la PFS mediana (6,4 vs. 3,3 mesi) e la percentuale di risposte (31,6% vs. 9,4%) erano risultati significativamente superiori con FOLFIRINOX. In tale studio, però, i pazienti in età maggiore di 75 anni e con ECOG PS maggiore o uguale a 2 non erano eleggibili.
Carcinoma della mammella metastatico
a) Everolimus
L’everolimus è stato approvato nel carcinoma della mammella avanzato con stato recettoriale ormonale positivo, in combinazione con exemestane, in donne in postmenopausa precedentemente trattate con un inibitore dell’aromatasi non steroideo (anastrozolo o letrozolo). L’everolimus è un inibitore di mTOR (Mammalian Target Of Rapamicin) che agisce inibendo selettivamente un’aberrante attivazione del pathway di mTOR che è uno dei meccanismi di resistenza alle terapie ormonali. Lo studio registrativo è uno studio di fase III randomizzato doppio cieco, controllato con placebo, eseguito in 742 pazienti, in post-menopausa, affette da carcinoma mammario avanzato, ER positivo, HER2 (Human Epidermal Growth Factor) negativo, resistente a terapia con inibitori dell’aromatasi non steroidei18 (anastrozolo e letrozolo). Le pazienti sono state randomizzate a ricevere everolimus+exemestane o exemestane da solo. Ambedue i farmaci sono stati somministrati per via orale alle dosi di 25mg/die l’exemestane e di 10mg/die l’everolimus. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Everolimus+exemestane ha determinato un miglioramento della PFS mediana da 4,1 mesi con exemestane a 10,6 mesi con la combinazione (+6,5 mesi). La percentuale di risposte era significativamente superiore con la combinazione (9,5% vs. 0,4%). Per quanto riguarda la sopravvivenza globale i risultati non sono ancora maturi. La combinazione ha però aumentato l’incidenza di eventi avversi: quelli di grado 3 o 4 più frequenti sono risultati la stomatite (8% vs. 1%), l’anemia (4% vs. 1%) l’iperglicemia (4% vs. 1%) e la polmonite non infettiva (3% vs. 1%). Il tempo al deterioramento della qualità di vita, misurata con il questionario EORTC QLQ - C30 e relativo modulo per il cancro della mammella, non era significativamente differente tra i due bracci. Il trattamento è stato sospeso per eventi avversi nel 19% delle pazienti trattate con la combinazione e nel 4% delle pazienti trattate con exemestane da solo. In conclusione l’everolimus migliora i risultati dell’exemestane in donne in progressione trattate con letrozolo o anastrozolo, ma, non avendo al momento dati relativi all’impatto sulla OS, il beneficio dell’aumento della PFS deve essere pesato rispetto agli effetti collaterali del trattamento. Quindi nella scelta della terapia con everolimus bisogna tener conto delle comorbidità delle pazienti, con particolare attenzione alla presenza di diabete mellito non controllato, di malattie polmonari con insufficienza respiratoria preesistente e del performance status della paziente.
Lo studio registrativo è uno studio di fase III randomizzato doppio cieco, controllato con placebo, eseguito in 742 pazienti, in post-menopausa, affette da carcinoma mammario avanzato, ER positivo, HER2 (Human Epidermal Growth Factor) negativo, resistente a terapia con inibitori dell’aromatasi non steroidei18 (anastrozolo e letrozolo). Le pazienti sono state randomizzate a ricevere everolimus+exemestane o exemestane da solo. Ambedue i farmaci sono stati somministrati per via orale alle dosi di 25mg/die l’exemestane e di 10mg/die l’everolimus. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Everolimus+exemestane ha determinato un miglioramento della PFS mediana da 4,1 mesi con exemestane a 10,6 mesi con la combinazione (+6,5 mesi). La percentuale di risposte era significativamente superiore con la combinazione (9,5% vs. 0,4%). Per quanto riguarda la sopravvivenza globale i risultati non sono ancora maturi. La combinazione ha però aumentato l’incidenza di eventi avversi: quelli di grado 3 o 4 più frequenti sono risultati la stomatite (8% vs. 1%), l’anemia (4% vs. 1%) l’iperglicemia (4% vs. 1%) e la polmonite non infettiva (3% vs. 1%). Il tempo al deterioramento della qualità di vita, misurata con il questionario EORTC QLQ - C30 e relativo modulo per il cancro della mammella, non era significativamente differente tra i due bracci. Il trattamento è stato sospeso per eventi avversi nel 19% delle pazienti trattate con la combinazione e nel 4% delle pazienti trattate con exemestane da solo. In conclusione l’everolimus migliora i risultati dell’exemestane in donne in progressione trattate con letrozolo o anastrozolo, ma, non avendo al momento dati relativi all’impatto sulla OS, il beneficio dell’aumento della PFS deve essere pesato rispetto agli effetti collaterali del trattamento. Quindi nella scelta della terapia con everolimus bisogna tener conto delle comorbidità delle pazienti, con particolare attenzione alla presenza di diabete mellito non controllato, di malattie polmonari con insufficienza respiratoria preesistente e del performance status della paziente.
b) Pertuzumab
Il 15-20% dei casi di tumore della mammella sono caratterizzati da un’amplificazione genica e/o da una iperespressione dell’HER2. Nel sottotipo HER2 positivo svolge un ruolo importante soprattutto l’eterodimerizzazione HER2-HER3, con conseguente aumento della proliferazione cellulare; ciò determina, nelle pazienti con neoplasia HER2 positiva, una prognosi peggiore rispetto a quelle con malattia HER2 negativa. Nelle pazienti con malattia HER2 positiva, l’associazione della chemioterapia con il trastuzumab, ha migliorato in maniera significativa la sopravvivenza. Tuttavia è frequente la comparsa di resistenza o refrattarietà al trattamento con conseguente necessità di sviluppare nuovi farmaci anti HER. Il pertuzumab è un anticorpo monoclonale diretto contro il dominio extracellulare dell’HER2, nell’epitopo deputato alla eterodimerizzazione recettoriale che viene conseguentemente impedita. Ha un meccanismo d’azione complementare a quello del trastuzumab, anticorpo monoclonale che lega sempre il dominio extracellulare di HER2, ma in un epitopo differente, quello deputato al clivaggio proteolitico del recettore. Il pertuzumab è stato approvato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti affette da carcinoma mammario HER2 positivo metastatico o localmente recidivato inoperabile, non trattate in precedenza o la cui malattia è recidivata dopo terapia adiuvante. Lo studio registrativo è uno studio clinico di fase III randomizzato, doppio cieco, controllato con placebo, condotto in 808 pazienti affette da carcinoma mammario HER2 positivo localmente avanzato non operabile o metastatico, non precedentemente sottoposto a chemioterapia o terapia biologica per la malattia metastatica19. Le pazienti sono state randomizzate a ricevere trastuzumab+docetaxel vs.pertuzumab+trastuzumab+docetaxel. Il pertuzumab è stato somministrato alla dose di 840mg ev seguiti da 420mg ev ogni 3 settimane; il trastuzumab alla dose di 8mg/kg seguito da 6mg/kg ev ogni 3 settimane e il docetaxel a dosi di 75mg/m2 ev ogni 3 settimane per almeno 6 cicli. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Il trattamento con pertuzumab, ha aumentato significativamente la PFS da 12,4 mesi nel braccio di controllo a 18,5 mesi (+6,1 mesi). La percentuale di risposte è cresciuta dal 69,3% all’80,2%. I dati sulla sopravvivenza globale non erano maturi al momento della pubblicazione dello studio. Tuttavia, ad una seconda analisi ad interim, il numero di decessi nel gruppo senza pertuzumab è risultato maggiore rispetto a quello con pertuzumab: 38% vs. 28% (con una riduzione dell’HR di morte del 34%)20. La OS mediana era 37,6 mesi nel braccio di controllo vs. una OS mediana non ancora raggiunta nel braccio trattato con pertuzumab. Gli eventi avversi erano simili tra i due gruppi di pazienti. La tossicità di grado 3 o 4 era più frequente con il pertuzumab in termini di neutropenia (48,9% vs. 45,8%), neutropenia febbrile (13,8% vs. 7,6%), diarrea (7,9% vs. 5,0%). Non si registrava un aumento della cardiotossicità (disfunzione sistolica del ventricolo sinistro). In conclusione il pertuzumab associato a trastuzumab e docetaxel è da considerare il trattamento standard in prima linea per pazienti con carcinoma della mammella metastatico o localmente avanzato HER2 positivo.
c) Ado-trastuzumab (Trastuzumab emtansine)
L’ado-trastuzumab emtansine (TDM-1) è un farmaco costituito dall’anticorpo monoclonale trastuzumab coniugato con un agente citotossico, un derivato della maitansina (DM-1). Il meccanismo d’azione del TDM-1 comprende quindi quello tipico del trastuzumab e quello del DM-1, capace di danneggiare i microtubuli cellulari con conseguente arresto delle mitosi e induzione dell’apoptosi. Il DM-1 viene veicolato dal trastuzumab soltanto nelle cellule che iperesprimono l’HER2 con conseguente aumento dell’indice terapeutico e riduzione dell’esposizione delle cellule normali. Il TDM-1 è stato approvato come singolo agente in pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato non operabile o metastatico, precedentemente trattate con trastuzumab e un taxano, separatamente o in combinazione. Il farmaco è stato autorizzato sulla base dei risultati di uno studio di fase III randomizzato eseguito in 991 pazienti affette da carcinoma mammario HER2 positivo non operabile, localmente avanzato o metastatico, precedentemente sottoposte a terapia con trastuzumab e un taxano ed in progressione. Le pazienti sono state randomizzate a ricevere lapatinib+capecitabina vs. TDM-1. Il TDM-1 è stato somministrato alla dose di 3,6mg/kg ev, ogni 3 settimane. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Il TDM-1 ha determinato un aumento della PFS mediana da 6,4 mesi a 9,6 mesi (+3,2 mesi). Anche la OS mediana era significativamente aumentata da 25,1 mesi a 30,9 mesi (+5,8 mesi)21. Infine, la percentuale di risposte aumentava significativamente dal 30,8% al 43,6%. Gli eventi avversi di grado 3 o 4 avevano un’incidenza significativamente superiore con lapatinib+capecitabina (57% vs. 41%), in particolare, la diarrea (20,7% vs. 1,6%), la nausea (2,5% vs. 0,8%), il vomito (4,5% vs. 0,8%) e la sindrome mani-piedi (16,4% vs. 0%). Invece, l’incidenza di trombocitopenia (12,9% vs. 0,2%) e l’aumento delle transaminasi (7,2% vs. 2,2%) erano più frequenti con TDM-1. In conclusione, TDM-1 è un farmaco più efficace e complessivamente meno tossico della combinazione lapatinib + capecitabina, pertanto è da considerare il trattamento standard delle pazienti con carcinoma della mammella metastatico HER2 positive dopo progressione ad una prima linea con trastuzumab e un taxano.
Il DM-1 viene veicolato dal trastuzumab soltanto nelle cellule che iperesprimono l’HER2 con conseguente aumento dell’indice terapeutico e riduzione dell’esposizione delle cellule normali. Il TDM-1 è stato approvato come singolo agente in pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato non operabile o metastatico, precedentemente trattate con trastuzumab e un taxano, separatamente o in combinazione. Il farmaco è stato autorizzato sulla base dei risultati di uno studio di fase III randomizzato eseguito in 991 pazienti affette da carcinoma mammario HER2 positivo non operabile, localmente avanzato o metastatico, precedentemente sottoposte a terapia con trastuzumab e un taxano ed in progressione. Le pazienti sono state randomizzate a ricevere lapatinib+capecitabina vs. TDM-1. Il TDM-1 è stato somministrato alla dose di 3,6mg/kg ev, ogni 3 settimane. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Il TDM-1 ha determinato un aumento della PFS mediana da 6,4 mesi a 9,6 mesi (+3,2 mesi). Anche la OS mediana era significativamente aumentata da 25,1 mesi a 30,9 mesi (+5,8 mesi)21. Infine, la percentuale di risposte aumentava significativamente dal 30,8% al 43,6%. Gli eventi avversi di grado 3 o 4 avevano un’incidenza significativamente superiore con lapatinib+capecitabina (57% vs. 41%), in particolare, la diarrea (20,7% vs. 1,6%), la nausea (2,5% vs. 0,8%), il vomito (4,5% vs. 0,8%) e la sindrome mani-piedi (16,4% vs. 0%). Invece, l’incidenza di trombocitopenia (12,9% vs. 0,2%) e l’aumento delle transaminasi (7,2% vs. 2,2%) erano più frequenti con TDM-1. In conclusione, TDM-1 è un farmaco più efficace e complessivamente meno tossico della combinazione lapatinib + capecitabina, pertanto è da considerare il trattamento standard delle pazienti con carcinoma della mammella metastatico HER2 positive dopo progressione ad una prima linea con trastuzumab e un taxano.
Carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione
a) Abiraterone
La resistenza alla castrazione del carcinoma della prostata metastatico ha fatto rivalutare il ruolo dei recettori degli androgeni. Sebbene il meccanismo biologico responsabile dello sviluppo della resistenza alla castrazione non sia stato completamente chiarito, sono stati descritti alcuni meccanismi tra cui l’attivazione dei recettori per gli androgeni indipendentemente dal ligando, l’amplificazione del gene dei recettori per gli androgeni e la conseguente iperespressione del recettore, le mutazioni del gene dei recettori che portano alla sua attivazione da parte di ligandi diversi dal testosterone, l’iperattivazione degli enzimi di sintesi degli androgeni, con il conseguente aumento delle concentrazioni intratumorali del testosterone. L’abiraterone è un inibitore del CYP17, l’enzima essenziale per la sintesi del testosterone, che pertanto blocca la sintesi degli androgeni nelle ghiandole surrenaliche, nei testicoli e nella ghiandola prostatica. Il farmaco è stato approvato, in combinazione con prednisone o prednisolone, per il trattamento del carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione in pazienti che hanno ricevuto una precedente chemioterapia con un taxano. Lo studio registrativo è uno studio randomizzato di fase III, doppio cieco, controllato con placebo, condotto in pazienti con malattia metastatica in progressione, precedentemente trattati con docetaxel. I pazienti proseguivano la loro terapia con LH-RH agonisti o antagonisti22. Lo studio ha incluso 1195 pazienti randomizzati a ricevere il solo prednisone o 1000mg di abiraterone (4 compresse da 250mg in unica somministrazione a digiuno almeno un’ora prima o due ore dopo i pasti) più prednisone 5mg due volte die. L’endpoint primario dello studio era la OS. La OS mediana era significativamente superiore con abiraterone più prednisone (15,8 vs. 11,2 mesi, +4,6 mesi, con un decremento del rischio di morte, HR, del 26%). Anche la PFS mediana (5,6 mesi vs. 3,6 mesi), il tempo alla progressione del PSA (10,2 vs. 6,6 mesi) e la percentuale di risposte del PSA (38,0% vs. 10,1%) erano significativamente superiori con abiraterone. Eventi avversi correlati all’aumento degli ormoni mineralcorticoidi come ritenzione di fluidi (31% vs. 21%), ipertensione (10% vs. 8%) e ipokaliemia (17% vs. 8%) erano più frequentemente riferiti da pazienti sottoposti ad abiraterone, ma in genere erano di grado 1-2. Recentemente, un altro studio randomizzato doppio cieco, controllato con placebo, ha confrontato le stesse terapie ma i pazienti, affetti da carcinoma della prostata resistente alla castrazione, metastatico in progressione, non avevano prima ricevuto la chemioterapia, erano asintomatici o lievemente sintomatici e con un ECOG PS di 0-123. Sono stati arruolati 1088 pazienti. Gli endpoint co-primari erano la PFS radiografica e la OS. La PFS mediana radiografica era risultata significativamente superiore con abiraterone (16,5 mesi vs. 8,3 mesi, con un incremento di 8,2 mesi ed un miglioramento del 47% dell’HR). La OS mediana non era stata ancora raggiunta nei pazienti sottoposti ad abiraterone mentre era di 27,2 mesi nel gruppo trattato con prednisone. L’incidenza degli effetti collaterali era simile a quella riscontrata nello studio precedente. Dopo la pubblicazione di questo studio si attende che gli enti regolatori approvino il farmaco con l’indicazione di poterlo usare anche prima della chemioterapia con docetaxel. In conclusione l’abiraterone ha avuto un impatto fortemente positivo in pazienti con carcinoma della prostata resistente alla castrazione, trattati o meno in precedenza con docetaxel.
b) Enzalutamide
L’enzalutamide è un antiandrogeno non steroideo che inibisce il pathway dei recettori per gli androgeni attraverso vari meccanismi; infatti, avendo un’alta affinità per i recettori inibisce competitivamente i ligandi dei recettori per gli androgeni, la traslocazione nucleare dei recettori per gli androgeni, il legame del complesso recettore-ligando al DNA, prevenendo l’attivazione di alcuni geni necessari per la crescita e la proliferazione delle cellule del carcinoma della prostata.È stata approvata per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione, la cui malattia ha progredito durante o dopo la terapia con docetaxel.La dose raccomandata del farmaco è 160mg (4 capsule da 40mg) in unica somministrazione giornaliera. Non è necessario associare steroidi. Lo studio registrativo è uno studio di fase III randomizzato, doppio cieco, controllato con placebo, condotto con 1199 pazienti in progressione dopo 1 o 2 regimi di chemioterapia di cui almeno uno contenente il docetaxel. L’endpoint primario dello studio era la OS24. La OS era significativamente superiore con enzalutamide (18,4 mesi vs. 13,6 mesi, +4,8 mesi, con una riduzione del rischio di morte del 37%). Anche gli endpoint secondari erano migliori con enzalutamide: PFS radiologica (8,3 mesi vs. 2,9 mesi), riduzione del PSA (54% vs. 2%), tempo alla progressione del PSA (8,3 mesi vs. 3,0 mesi), tempo al primo evento scheletrico (16,7 mesi vs. 13,3 mesi). La percentuale di eventi avversi era simile nei due bracci dello studio. Addirittura l’enzalutamide presentava una minor incidenza di eventi avversi di grado 3 o 4, sebbene nei pazienti trattati con tale farmaco vi fosse un’incidenza più alta di tutti i gradi di fatigue (34% vs. 29%), diarrea (21% vs. 18%), vampate di calore (20% vs. 10%), dolori muscoloscheletrici (14% vs. 10%) e cefalea (12% vs. 6%). Solo l’8% dei pazienti sottoposti ad enzalutamide ha interrotto il trattamento per eventi avversi. In conclusione, l’enzalutamide è un trattamento efficace e poco tossico in pazienti con carcinoma della prostata resistente alla castrazione in progressione durante o dopo chemioterapia con docetaxel.
Melanoma maligno metastatico
Dopo più di 20 anni trascorsi senza alcuna novità terapeutica di rilievo nel melanoma metastatico, recentemente sono entrati in commercio prima il vemurafenib e l’ipilimumab e fra poco arriveranno il dabrafenib e il trametinib.
a) Vemurafenib e Dabrafenib
Il vemurafenib e il dabrafenib sono inibitori di BRAF, una protein-chinasi che fa parte della famiglia delle RAF chinasi coinvolte nella cascata di trasduzione del segnale delle MAP (Mitogen Activated Protein) kinasi. Circa il 50% pazienti con melanoma hanno una mutazione di BRAF, in gran parte dei casi è presente la mutazione V600E, più raramente quella V600K. La mutazione determina l’attivazione di BRAF che agisce attivando MEK che a sua volta attiva ERK, effettore finale delle MAPK, con conseguente stimolo alla proliferazione e all’aumento della sopravvivenza delle cellule tumorali. La registrazione del vemurafenib è avvenuta sulla base dei risultati di uno studio randomizzato di fase III, di confronto con la dacarbazina, come prima linea di terapia in 675 pazienti affetti da melanoma metastatico con mutazione V600E25. Vemurafenib è stato usato a dosi di 960mg per via orale 2 volte al giorno. Gli endpoint primari erano la PFS e la OS. Il crossover dei pazienti trattati con dacarbazina al vemurafenib era previsto solo dopo che con il vemurafenib fosse stato dimostrato un aumento statisticamente significativo della OS (non della sola PFS). Un’analisi ad interim ha evidenziato un aumento significativo della OS mediana a 6 mesi con vemurafenib (da 64% a 84%), della PFS (da 1,6 vs. 5,3 mesi) e della percentuale di risposte obiettive (dal 5% al 48%). Tali risultati sono stati aggiornati a 12 mesi di follow up: la OS era aumentata dal 43% al 55% e la OS mediana da 9,6 mesi a 13,2 mesi26. Il vemurafenib rappresenta, dunque, la prima novità terapeutica importante negli ultimi 20 anni. C’è da aggiungere che questi risultati sono simili a quelli ottenuti nello studio registrativo del dabrafenib. Recentemente approvato dall’EMA, il dabrafenib è il secondo BRAF inibitore. Lo studio randomizzato ha confrontato il dabrafenib, somministrato a dosi di 150mg per os 2 volte al giorno, con la dacarbazina in pazienti con melanoma BRAF mutato V600E27. L’endpoint primario dello studio era la PFS. In 250 pazienti, randomizzati 2:1 la PFS mediana era significativamente superiore con il dabrafenib (5,1 vs. 2,7 mesi), così come aumentati erano la OS (diminuzione dell’HR di morte del 39%, anche se è necessario un follow up più lungo per avere dati più consistenti) e la percentuale di risposte obiettive (50% vs. 4%).
b) Trametinib
Un altro importante passo in avanti è stata la dimostrazione dell’efficacia di un MEK inibitore, il trametinib, importante nel pathway delle MAP kinasi. Il farmaco è stato valutato in uno studio di fase III randomizzato, alla dose di 2mg/die per via orale, rispetto alla chemioterapia (dacarbazina o paclitaxel) in pazienti che non avevano ricevuto prima BRAF inibitori ed ipilimumab28. I pazienti potevano aver ricevuto una prima linea di chemioterapia e alla progressione potevano eseguire il crossover. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Lo studio ha arruolato 322 pazienti con mutazione BRAF. La PFS mediana è stata significativamente superiore con il trametinib (4,8 vs. 1,5 mesi) così come la OS a 6 mesi nonostante vi fosse il crossover (81% vs. 67%). La percentuale di risposte era del 25% vs. 8% rispettivamente. Sulla base di questi risultati il farmaco è stato approvato dalla FDA ed è stato sottoposto alla valutazione dell’EMA. Questi farmaci sembrano aver modificato, almeno in parte, la storia naturale del melanoma metastatico. Purtroppo oltre il 50% dei pazienti trattati con BRAF e MEK inibitori ha una progressione della malattia dopo circa sei mesi di trattamento. Una possibilità di superare i meccanismi di resistenza (ne sono stati descritti molti) è la combinazione del BRAF con il MEK inibitore che in uno studio di fase I-II, recentemente pubblicato, ha dimostrato di indurre un significativo incremento della PFS mediana (9,4 mesi vs. 5,8 mesi) così come un aumento della percentuale di risposte (76% vs. 54%)29. Ovviamente siamo in attesa dei risultati dello studio di fase III.
c) Ipilimumab
L’ipilimumab è un anticorpo monoclonale che blocca il cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA4), un posto di blocco sulla superficie dei linfociti T, con conseguente attivazione dei linfociti T stessi. Il farmaco viene somministrato in infusione di 90 minuti ogni 3 settimane per 4 volte alla dose di 3mg/kg. Lo studio registrativo è uno studio di fase III di confronto fra tre trattamenti eseguito in 676 pazienti: ipilimumab in combinazione con gp100 (un vaccino basato su un antigene del melanoma), ipilimumab da solo e gp100 da solo30. Lo studio era pianificato per valutare una differenza nella percentuale di risposte fra i tre trattamenti. In corso di studio, tale endpoint è stato sostituito dalla OS. La OS mediana era significativamente superiore con la combinazione o con ipilimumab da solo rispetto al gp100 (10,0 vs. 10,1 vs. 6,4 mesi rispettivamente). La PFS mediana era simile tra i tre bracci di trattamento (2,8, 2,9, e 2,8 mesi, rispettivamente). Di fatto il farmaco dà una falsa progressione iniziale della malattia, dovuta ad un aumento dell’infiammazione peritumorale, che giustifica tali risultati. Le risposte avvengono, infatti, lentamente ma talora sono di lunga durata. In un altro studio condotto con 502 pazienti, l’ipilimumab in combinazione con dacarbazina è stato confrontato in prima linea di terapia con dacarbazina da sola31. La OS mediana, endpoint primario dello studio, era risultata significativamente superiore con la combinazione (11,2 vs. 9,1 mesi). La PFS era simile tra i due trattamenti. La tossicità era aumentata dalla combinazione. Tutti i farmaci per il melanoma recentemente introdotti presentano tossicità importanti; l’ipilimumab principalmente di tipo immunologico sulla cute, il tratto gastroenterico ed il fegato; i BRAF inibitori tossicità cutanea (rash cutaneo, eritrodisestesia palmo - plantare, cheratoacantomi e carcinomi spinocellulari), fatigue e artralgie; i MEK inibitori tossicità cutanea, diarrea, edemi periferici. Per la descrizione delle tossicità di tali farmaci e della prevenzione/trattamento si rimanda a revisioni recentemente pubblicate sulla rivista CASCO del Pensiero Scientifico.
Glioblastoma multiforme
Il bevacizumab è approvato nel glioblastoma solo in Giappone e negli Stati Uniti come monoterapia del glioblastoma recidivato inoperabile e non più irradiabile. Recentemente sono stati pubblicati due importanti studi sul bevacizumab associato a radioterapia e temozolomide come prima linea di trattamento del glioblastoma. Lo studio americano, doppio cieco controllato con placebo, è incentrato sull’aggiunta o meno del bevacizumab alla radioterapia e alla temozolomide. Esso è stato finanziato dal National Cancer Institute americano, che ha fornito anche il farmaco, e nonostante il gruppo di studio avesse ricevuto un supporto (unrestricted educational grant) dalla Genentech, la raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei risultati così come la stesura del manoscritto è stata eseguita dai ricercatori in maniera indipendente dall’industria. Il farmaco, alla dose di 10mg/kg ogni 14 giorni, veniva aggiunto durante la 4a settimana di radioterapia ed era continuato fino alla progressione di malattia o, al massimo, per 24 somministrazioni ogni 14 giorni come terapia di mantenimento32. Per i pazienti trattati con placebo, alla progressione di malattia era permesso il crossover. Gli endpoint primari erano la PFS e la OS. Sono entrati nello studio 637 pazienti. La OS mediana non era significativamente differente tra i due gruppi di pazienti (15,7 mesi con bevacizumab e 16,1 mesi con placebo). La PFS mediana invece era significativamente superiore con bevacizumab (10,7 mesi vs. 7,3 mesi, con un incremento del 21% dell’HR). Gli effetti collaterali erano modesti ma più marcati con il bevacizumab. L’impatto del bevacizumab sulla qualità di vita e sulle funzioni neurocognitive dei pazienti era risultato negativo. Lo studio AVAglio, randomizzato doppio cieco, ha confrontato il bevacizumab con il placebo in pazienti sottoposti in prima linea a radioterapia più temozolomide33. Il bevacizumab era somministrato ogni 14 giorni alla dose di 10mg/kg. Durante la fase di mantenimento, il farmaco era somministrato ogni 14 giorni per sei cicli di 4 settimane associato alla temozolomide e poi a dosi di 15mg/kg ogni 3 settimane fino a progressione. Lo studio era sponsorizzato dalla Genentech che ha raccolto ed elaborato i dati; in seguito, un medical writer ha scritto il report che è stato approvato dagli “autori”. La OS mediana e la PFS mediana erano gli endpoint coprimari. Sono stati arruolati 921 pazienti. La PFS mediana aumentava con il bevacizumab da 6,2 a 10,6 mesi (con un decremento dell’HR del 36%); purtroppo anche in questo studio la OS mediana non era significativamente differente (16,8 vs. 16,7 mesi, rispettivamente). La qualità di vita ed il performance status erano mantenuti più a lungo stabili nei pazienti trattati con bevacizumab che, peraltro, richiedevano meno frequentemente corticosteroidi. Anche in questo studio la tossicità era maggiore nel braccio con bevacizumab.Riassumendo due studi, con simili disegno, caratteristiche dei pazienti ed endpoint primari, hanno evidenziato un quasi uguale aumento della PFS, ma non un’efficacia in termini di OS. I risultati circa l’impatto sulla qualità di vita nei due studi sono contrastanti. Infine, come prevedibile, in entrambi gli studi è stata riscontrata una maggior tossicità con il bevacizumab. Come interpretare tali risultati? Alcuni sostengono che essendo il crossover avvenuto in circa la metà dei pazienti sottoposti a placebo questo potrebbe aver diluito l’impatto del bevacizumab sulla OS. Di norma, un trattamento che aumenta la PFS ma non la OS è da trasferire nella pratica clinica se la qualità di vita è migliorata o è da rigettare se la qualità di vita peggiora. Nel nostro caso, nei due studi è stato registrato un diverso e contrastante impatto dei trattamenti sulla qualità di vita. La conclusione più sensata sarebbe quella di fare un altro studio su un ampio numero di pazienti senza permettere il crossover o, almeno, consentendolo solo quando si fosse raggiunta una ragionevole certezza della maggior efficacia del bevacizumab in termini di OS.
Esso è stato finanziato dal National Cancer Institute americano, che ha fornito anche il farmaco, e nonostante il gruppo di studio avesse ricevuto un supporto (unrestricted educational grant) dalla Genentech, la raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei risultati così come la stesura del manoscritto è stata eseguita dai ricercatori in maniera indipendente dall’industria. Il farmaco, alla dose di 10mg/kg ogni 14 giorni, veniva aggiunto durante la 4a settimana di radioterapia ed era continuato fino alla progressione di malattia o, al massimo, per 24 somministrazioni ogni 14 giorni come terapia di mantenimento32. Per i pazienti trattati con placebo, alla progressione di malattia era permesso il crossover. Gli endpoint primari erano la PFS e la OS. Sono entrati nello studio 637 pazienti. La OS mediana non era significativamente differente tra i due gruppi di pazienti (15,7 mesi con bevacizumab e 16,1 mesi con placebo). La PFS mediana invece era significativamente superiore con bevacizumab (10,7 mesi vs. 7,3 mesi, con un incremento del 21% dell’HR). Gli effetti collaterali erano modesti ma più marcati con il bevacizumab. L’impatto del bevacizumab sulla qualità di vita e sulle funzioni neurocognitive dei pazienti era risultato negativo. Lo studio AVAglio, randomizzato doppio cieco, ha confrontato il bevacizumab con il placebo in pazienti sottoposti in prima linea a radioterapia più temozolomide33. Il bevacizumab era somministrato ogni 14 giorni alla dose di 10mg/kg. Durante la fase di mantenimento, il farmaco era somministrato ogni 14 giorni per sei cicli di 4 settimane associato alla temozolomide e poi a dosi di 15mg/kg ogni 3 settimane fino a progressione. Lo studio era sponsorizzato dalla Genentech che ha raccolto ed elaborato i dati; in seguito, un medical writer ha scritto il report che è stato approvato dagli “autori”. La OS mediana e la PFS mediana erano gli endpoint coprimari. Sono stati arruolati 921 pazienti. La PFS mediana aumentava con il bevacizumab da 6,2 a 10,6 mesi (con un decremento dell’HR del 36%); purtroppo anche in questo studio la OS mediana non era significativamente differente (16,8 vs. 16,7 mesi, rispettivamente). La qualità di vita ed il performance status erano mantenuti più a lungo stabili nei pazienti trattati con bevacizumab che, peraltro, richiedevano meno frequentemente corticosteroidi. Anche in questo studio la tossicità era maggiore nel braccio con bevacizumab.Riassumendo due studi, con simili disegno, caratteristiche dei pazienti ed endpoint primari, hanno evidenziato un quasi uguale aumento della PFS, ma non un’efficacia in termini di OS. I risultati circa l’impatto sulla qualità di vita nei due studi sono contrastanti. Infine, come prevedibile, in entrambi gli studi è stata riscontrata una maggior tossicità con il bevacizumab. Come interpretare tali risultati? Alcuni sostengono che essendo il crossover avvenuto in circa la metà dei pazienti sottoposti a placebo questo potrebbe aver diluito l’impatto del bevacizumab sulla OS. Di norma, un trattamento che aumenta la PFS ma non la OS è da trasferire nella pratica clinica se la qualità di vita è migliorata o è da rigettare se la qualità di vita peggiora. Nel nostro caso, nei due studi è stato registrato un diverso e contrastante impatto dei trattamenti sulla qualità di vita. La conclusione più sensata sarebbe quella di fare un altro studio su un ampio numero di pazienti senza permettere il crossover o, almeno, consentendolo solo quando si fosse raggiunta una ragionevole certezza della maggior efficacia del bevacizumab in termini di OS.
Carcinoma del polmone non microcitoma
Gli inibitori dell’epidermal growth factor receptor (EGFR), erlotinib e gefitinib, hanno determinato in almeno 5-6 studi controllati, eseguiti in pazienti con adenocarcinoma del polmone con mutazione dell’EGFR, una PFS mediana significativamente superiore rispetto alla chemioterapia di prima linea a base di cisplatino. Non sono state evidenziate differenze in termini di OS mediana in quanto ai pazienti del gruppo di controllo, alla progressione di malattia, era stato consentito il crossover con la terapia contenente erlotinib o gefitinib.
a) Afatinib
L’afatinib è il terzo inibitore dell’EGFR, un inibitore irreversibile, approvato per la prima linea di terapia per i pazienti con adenocarcinoma del polmone con mutazione dell’EGFR. Lo studio registrativo era uno studio di fase III in prima linea di terapia (studio LUX-lung 3), che ha confrontato afatinib versus la combinazione di cisplatino e pemetrexed in pazienti prevalentemente asiatici con adenocarcinoma del polmone localmente avanzato o disseminato. Sono entrati nello studio 345 pazienti: 230 hanno ricevuto afatinib 40 mg os die e 115 la chemioterapia. L’endpoint primario era la PFS. La PFS mediana era significativamente aumentata da 6,9 mesi con la chemioterapia a 11,1 mesi con afatinib (riduzione dell’HR del 42%). Anche la percentuale di risposte ottenute era significativamente superiore con afatinib (56% vs. 23%). La OS mediana non era invece significativamente differente (16,6 mesi vs. 14,8 mesi)34, probabilmente perché, alla progressione, i pazienti potevano scegliere il crossover al trattamento sperimentale. In tale studio è stato anche valutato l’impatto dei trattamenti sulla qualità di vita, usando il questionario EORTC QLQ-C30 più il modulo per le neoplasie polmonari. Il tempo al deterioramento dei sintomi, specie tosse e dispnea, ma non il dolore, era significativamente più lungo con afatinib35. L’incidenza degli effetti collaterali di grado 3 o 4 non era significativamente differente tra i due gruppi di pazienti (49% vs. 48%). Ma diarrea, rash cutaneo, secchezza ed irritazione della cute e delle mucose erano più frequenti con afatinib, mentre diminuzione di appetito, fatigue, nausea e vomito e mielosoppressione si presentavano più spesso nel braccio di chemioterapia. Questi risultati sono stati recentemente confermati da un altro studio, eseguito in pazienti asiatici con mutazione EGFR, che ha confrontato afatinib versus la combinazione di cisplatino e gemcitabina in prima linea di trattamento36. I pazienti erano randomizzati 2:1 a ricevere afatinib (242 pazienti) o cisplatino più gemcitabina (122 pazienti). Anche in questo studio la PFS era l’endpoint primario. La PFS mediana era significativamente aumentata da 5.6 mesi a 11,0 mesi. Anche la percentuale di risposte era superiore con afatinib (66,9% vs. 23%). La OS mediana era rispettivamente di 22,1 mesi vs. 22,2 mesi, ma anche in questo caso, come nello studio registrativo, vi era stato un crossover di circa il 48% dei pazienti. I risultati ottenuti con afatinib sono simili a quelli di gefitinib e erlotinib. Vi è un’apparente maggior tossicità di afatinib rispetto a gefitinib e erlotinib, specie in termini di rash cutanei e diarrea, ma questa impressione deve essere verificata in studi clinici di confronto attualmente in corso i cui risultati non sono ancora noti. Pertanto, al momento, la scelta tra i tre farmaci in prima linea di chemioterapia nei pazienti con adenocarcinoma del polmone EGFR mutato dovrebbe essere basata sul costo del trattamento.
Vi è un’apparente maggior tossicità di afatinib rispetto a gefitinib e erlotinib, specie in termini di rash cutanei e diarrea, ma questa impressione deve essere verificata in studi clinici di confronto attualmente in corso i cui risultati non sono ancora noti. Pertanto, al momento, la scelta tra i tre farmaci in prima linea di chemioterapia nei pazienti con adenocarcinoma del polmone EGFR mutato dovrebbe essere basata sul costo del trattamento.
b) Crizotinib
Mutazioni o traslocazioni del gene ALK (anaplastic lymphoma kinase) sono state osservate in alcune neoplasie tra le quali il carcinoma non microcitoma del polmone, in particolare l’adenocarcinoma. In questa patologia, l’alterazione genetica è presente in circa il 5% dei pazienti e i risultati di studi di fase I-II con il crizotinib, un inibitore dell’ALK, hanno evidenziato risposte nel 60% circa dei pazienti ed una PFS di 8,1-9,7 mesi. Il farmaco è stato approvato per il trattamento del carcinoma del polmone non microcitoma, localmente avanzato o metastatico, ALK positivo precedentemente trattato con chemioterapia di prima linea a base di cisplatino. Lo studio che ha portato alla registrazione del farmaco è uno studio di fase III eseguito in 347 pazienti (oltre il 95% adenocarcinomi), randomizzati a ricevere, come seconda linea di terapia, crizotinib 250 mg due volte die o chemioterapia con pemetrexed o docetaxel37. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Alla progressione era consentito il crossover. La PFS era significativamente superiore con il crizotinib (7,7 mesi vs. 3,0 mesi, riduzione del rischio di progressione del 51%). La OS mediana era simile nei due gruppi di pazienti (20,3 vs. 22,8 mesi, rispettivamente). Ovviamente va considerato che il 64% dei pazienti trattati con chemioterapia hanno poi ricevuto il crizotinib. Una maggiore frazione di pazienti trattati con crizotinib presentarono una riduzione dei sintomi della neoplasia ed un miglioramento della qualità di vita misurata con il questionario QLQ-C30 + relativo modulo per il carcinoma del polmone.
Carcinoma del rene metastatico
L’axitinib è un inibitore potente e selettivo del recettore del VEGF che aveva dimostrato di essere attivo in studi di fase II in pazienti resistenti alle citochine e al sorafenib. Il farmaco è stato approvato in seconda linea di terapia del carcinoma renale metastatico in seguito ai risultati di uno studio di fase III che ha confrontato axitinib (5mg bid) con sorafenib (400mg bid)38. L’endpoint primario dello studio era la PFS. Nei 723 pazienti arruolati, la PFS mediana è risultata significativamente superiore con axitinib (6,7 mesi vs. 4,7 mesi). Il beneficio osservato era superiore nei pazienti che, in prima linea, avevano ricevuto citochine rispetto a quelli che avevano ricevuto sunitinib. Anche la percentuale di risposte era superiore con axitinib (19% vs. 9%). La OS mediana, i cui risultati sono stati riportati più recentemente39, non era però significativamente differente fra i due trattamenti (20,1 vs. 19,2 mesi). Da tale punto di vista è importante sottolineare che ai pazienti non era consentito il crossover al trattamento sperimentale che avrebbe potuto ridurre l’impatto sulla OS mediana dell’axitinib. Gli eventi avversi più comuni erano ipertensione, diarrea e fatigue con axitinib ed eritrodisestesia palmo - plantare e alopecia con sorafenib. Il tempo mediano al deterioramento dei sintomi era a favore dell’axitinib probabilmente perché i pazienti avevano una progressione della malattia più tardiva. In seguito alla progressione di malattia il tempo al deterioramento dei sintomi diminuiva verso il fine vita. Il mancato impatto sulla OS mediana e il modesto miglioramento della PFS mediana permette di poter concludere che l’axitinib aggiunge poco in termini di efficacia al sorafenib. Inoltre, un altro studio, in cui si confrontava il sorafenib con l’axitinib in prima linea di terapia del carcinoma metastatico del rene, non ha evidenziato alcun beneficio del farmaco rispetto al sorafenib40.
Carcinoma metastatico dell'ovaio
È stato documentato che l’angiogenesi gioca un ruolo importante nella crescita e nella metastatizzazione del carcinoma ovarico. Su queste basi si è sviluppata la ricerca nel carcinoma dell’ovaio con un inibitore del VEGF, il bevacizumab. Due studi controllati hanno portato alla registrazione del bevacizumab nel carcinoma epiteliale dell’ovaio, delle tube di falloppio e nel carcinoma primitivo peritoneale, stadi FIGO III (non completamente resecabile) e IV. Lo studio GOG-0218 è uno studio doppio cieco in cui i pazienti erano randomizzati a ricevere: a) carboplatino+paclitaxel (gruppo di controllo), b) l’aggiunta al carboplatino+paclitaxel di bevacizumab alla dose di 15mg/kg ogni 3 settimane dal 2° al 6° ciclo di chemioterapia, c) oltre al bevacizumab nei primi 6 cicli una dose di mantenimento ogni 21 giorni fino ad un totale di 21 cicli (15 mesi di terapia)41. L’endpoint principale inizialmente era la OS, ma secondo quanto riferito dagli autori, è stato poi cambiato con la PFS in quanto lo studio non sarebbe stato più fattibile per le critiche degli investigatori e delle pazienti. Pertanto, considerando che solo se si fosse mantenuto in cieco il trattamento dopo la progressione della malattia si sarebbe potuto evitare il crossover, la valutazione accurata dell’impatto del bevacizumab sulla OS non è stata possibile. È stata ritenuta necessaria una numerosità di 1800 pazienti per evidenziare con il 90% di probabilità una riduzione del rischio di progressione o morte del 23% con l’aggiunta del bevacizumab. Sono entrati nello studio 1873 pazienti. La PFS mediana è stata di 10,3 mesi nel gruppo di controllo, 11,2 mesi con 5 cicli di bevacizumb e 14,1 mesi con 21 cicli di bevacizumab (riduzione del rischio di circa il 10% e del 28%, rispettivamente). La OS mediana non era significativamente differente (39,3, 38,7 e 39,7 mesi, rispettivamente) così come l’impatto del bevacizumab sulla qualità di vita valutata con il questionario FACT. Come previsto, l’incidenza di eventi avversi era aumentata con l’aggiunta del bevacizumab. Il secondo studio (ICON7), uno studio open, che includeva oltre i III e IV stadi anche gli stadi I e II ad alto rischio, randomizzava le pazienti a ricevere carboplatino+paclitaxel ogni 3 settimane per 6 cicli o la stessa combinazione di chemioterapia associata a bevacizumab (7,5mg/kg ogni 3 settimane), somministrato a partire dal 2° ciclo fino al 6° ciclo e poi continuato per ulteriori 12 cicli42. Gli endpoint co-primari erano la PFS e la OS. Per la PFS mediana era considerato clinicamente rilevante un aumento da 18 a 23 mesi con l’aggiunta del bevacizumab (5 mesi in più; decremento dell’HR del 28%), mentre per la OS mediana un aumento da 43 mesi a 53 mesi (10 mesi in più, decremento dell’HR di morte del 23%). Lo studio ha arruolato 1528 pazienti. La PFS mediana a 36 mesi aumentava significativamente da 20,3 mesi a 21,8 mesi (1,5 mesi in più; decremento dell’HR del 19%). A 42 mesi la PFS era 22,4 vs. 24,1 mesi in favore del bevacizumab (1,7 mesi in più). Ad un’analisi per sottogruppi, le pazienti a più alto rischio sembravano essere quelle che traevano un maggior beneficio in termini di incremento della PFS dall’aggiunta del bevacizumab. I dati sulla OS erano ancora prematuri alla pubblicazione dello studio e comunque non significativamente differenti. La qualità della vita, valutata a 54 settimane con il questionario dell’EORTC QLQ-C30 e relativo modulo per il carcinoma dell’ovaio, era superiore nelle pazienti sottoposte solo a chemioterapia. Quindi, continuare il trattamento con bevacizumab comporta un piccolo, ma clinicamente rilevante, peggioramento della qualità di vita43. Come c’era da attendersi, la tossicità era superiore con bevacizumab. Per decidere quale strategia terapeutica adottare nel carcinoma metastatico dell’ovaio in prima linea è necessario fare alcune considerazioni. Nel 2006 un workshop organizzato da Food and Drug Administration (FDA), American Society of Clinical Oncology (ASCO), American Association for Cancer Research (AACR) stabiliva che la PFS era un buon endpoint surrogato della OS nel carcinoma ovarico sottoposto ad una prima linea di chemioterapia44. Dati più recenti sembrano smentire tale opinione. Risultati ottenuti con l’impiego di modelli statistici, infatti, hanno suggerito che la correlazione tra PFS e OS è più debole in malattie con una più lunga sopravvivenza dopo la progressione (>12 mesi), mentre è un buon endpoint quando la sopravvivenza dopo la progressione è <12 mesi45. Tale constatazione è stata confermata di recente dall’analisi della correlazione tra PFS e OS, nei bracci di controllo e in quelli sperimentali, condotta sui risultati degli studi clinici randomizzati che hanno portato all’approvazione dei nuovi farmaci negli ultimi 10 anni46. Quindi, nelle neoplasie con breve sopravvivenza dopo la progressione (polmone, pancreas) la PFS potrebbe essere un buon endpoint surrogato, ma ciò ha uno scarso significato clinico in quanto per queste neoplasie è fattibile disegnare studi per evidenziare benefici in termini di OS. Mentre nelle neoplasie con lunga sopravvivenza dopo la progressione, come il cancro dell’ovaio o della mammella, la PFS non è clinicamente importante a meno che non sia associata ad un miglioramento dei Patient Reported Outcomes (PRO), come la qualità di vita. Purtroppo nei due studi in prima linea del bevacizumab l’aumento della PFS non solo non si accompagna ad un aumento della OS ma non produce neppure un miglioramento della qualità di vita o dei sintomi delle pazienti. Anzi in uno dei due studi, continuare il bevacizumab oltre i sei mesi di chemioterapia peggiorava di poco, ma in modo clinicamente rilevante, la qualità di vita. Talora si ha la sensazione di ripercorrere la storia del bevacizumab nel carcinoma della mammella: dati entusiasmanti sulla PFS ma poi nessun beneficio sulla OS e neanche sulla qualità di vita: ci si chiede di cosa sia surrogato l’endpoint PFS. A ciò va aggiunto che le analisi farmacoeconomiche pubblicate sembrano evidenziare la non costo - efficacia del trattamento47, 48.
Il secondo studio (ICON7), uno studio open, che includeva oltre i III e IV stadi anche gli stadi I e II ad alto rischio, randomizzava le pazienti a ricevere carboplatino+paclitaxel ogni 3 settimane per 6 cicli o la stessa combinazione di chemioterapia associata a bevacizumab (7,5mg/kg ogni 3 settimane), somministrato a partire dal 2° ciclo fino al 6° ciclo e poi continuato per ulteriori 12 cicli42. Gli endpoint co-primari erano la PFS e la OS. Per la PFS mediana era considerato clinicamente rilevante un aumento da 18 a 23 mesi con l’aggiunta del bevacizumab (5 mesi in più; decremento dell’HR del 28%), mentre per la OS mediana un aumento da 43 mesi a 53 mesi (10 mesi in più, decremento dell’HR di morte del 23%). Lo studio ha arruolato 1528 pazienti. La PFS mediana a 36 mesi aumentava significativamente da 20,3 mesi a 21,8 mesi (1,5 mesi in più; decremento dell’HR del 19%). A 42 mesi la PFS era 22,4 vs. 24,1 mesi in favore del bevacizumab (1,7 mesi in più). Ad un’analisi per sottogruppi, le pazienti a più alto rischio sembravano essere quelle che traevano un maggior beneficio in termini di incremento della PFS dall’aggiunta del bevacizumab. I dati sulla OS erano ancora prematuri alla pubblicazione dello studio e comunque non significativamente differenti. La qualità della vita, valutata a 54 settimane con il questionario dell’EORTC QLQ-C30 e relativo modulo per il carcinoma dell’ovaio, era superiore nelle pazienti sottoposte solo a chemioterapia. Quindi, continuare il trattamento con bevacizumab comporta un piccolo, ma clinicamente rilevante, peggioramento della qualità di vita43. Come c’era da attendersi, la tossicità era superiore con bevacizumab. Per decidere quale strategia terapeutica adottare nel carcinoma metastatico dell’ovaio in prima linea è necessario fare alcune considerazioni. Nel 2006 un workshop organizzato da Food and Drug Administration (FDA), American Society of Clinical Oncology (ASCO), American Association for Cancer Research (AACR) stabiliva che la PFS era un buon endpoint surrogato della OS nel carcinoma ovarico sottoposto ad una prima linea di chemioterapia44. Dati più recenti sembrano smentire tale opinione. Risultati ottenuti con l’impiego di modelli statistici, infatti, hanno suggerito che la correlazione tra PFS e OS è più debole in malattie con una più lunga sopravvivenza dopo la progressione (>12 mesi), mentre è un buon endpoint quando la sopravvivenza dopo la progressione è <12 mesi45. Tale constatazione è stata confermata di recente dall’analisi della correlazione tra PFS e OS, nei bracci di controllo e in quelli sperimentali, condotta sui risultati degli studi clinici randomizzati che hanno portato all’approvazione dei nuovi farmaci negli ultimi 10 anni46. Quindi, nelle neoplasie con breve sopravvivenza dopo la progressione (polmone, pancreas) la PFS potrebbe essere un buon endpoint surrogato, ma ciò ha uno scarso significato clinico in quanto per queste neoplasie è fattibile disegnare studi per evidenziare benefici in termini di OS. Mentre nelle neoplasie con lunga sopravvivenza dopo la progressione, come il cancro dell’ovaio o della mammella, la PFS non è clinicamente importante a meno che non sia associata ad un miglioramento dei Patient Reported Outcomes (PRO), come la qualità di vita. Purtroppo nei due studi in prima linea del bevacizumab l’aumento della PFS non solo non si accompagna ad un aumento della OS ma non produce neppure un miglioramento della qualità di vita o dei sintomi delle pazienti. Anzi in uno dei due studi, continuare il bevacizumab oltre i sei mesi di chemioterapia peggiorava di poco, ma in modo clinicamente rilevante, la qualità di vita. Talora si ha la sensazione di ripercorrere la storia del bevacizumab nel carcinoma della mammella: dati entusiasmanti sulla PFS ma poi nessun beneficio sulla OS e neanche sulla qualità di vita: ci si chiede di cosa sia surrogato l’endpoint PFS. A ciò va aggiunto che le analisi farmacoeconomiche pubblicate sembrano evidenziare la non costo - efficacia del trattamento47, 48.
Carcinoma midollare della tiroide localmente avanzato o metastatico
Il carcinoma midollare della tiroide, che origina dalle cellule parafollicolari C, rappresenta il 5% di tutte le neoplasie della tiroide e si presenta sia in forma sporadica che ereditaria. Fino a poco tempo fa in pazienti con carcinoma metastatico non c’erano terapie adeguate, dato che la chemioterapia è poco o per nulla efficace. Tutti i pazienti con malattia ereditaria e circa il 50% di quelli con neoplasia sporadica presentano una mutazione del protoncogene REarranged during Transfection (RET). Inoltre, anche il VEGF e l’Epidermal Growth Factor (EGF) sono coinvolti nella crescita e nell’invasività del carcinoma midollare della tiroide.
a) Vandetanib
Il vandetanib inibisce selettivamente il segnale RET, e i recettori del VEGF e dell’EGF. Due studi di fase II hanno evidenziato l’attività del vandetanib nel carcinoma midollare della tiroide localmente avanzato o metastatico: è stata riportata una percentuale di risposte parziali dal 15 al 20%, e la stabilità della malattia da circa il 50% dei pazienti. Successivamente, in uno studio in doppio cieco di fase III, il vandetanib, alla dose di 300mg/die per os, è stato confrontato con il placebo. I pazienti sono stati randomizzati 2:1. L’endpoint primario dello studio era la PFS49. Sono stati arruolati 331 pazienti con carcinoma midollare della tiroide localmente avanzato o metastatico. Dopo 24 mesi di follow-up, la PFS era significativamente aumentata con il vandetanib rispetto al placebo (mediana stimata 30,5 mesi vs. 19,3 mesi). Anche la percentuale di risposte era significativamente a favore del vandetanib (45% vs. 13%). Il farmaco si è rivelato tossico, in particolare i pazienti trattati con vandetanib riferivano una maggiore incidenza di diarrea (56% vs. 26%), nausea (33% vs. 16%), ipertensione (32% vs. 5%) e cefalea (26% vs. 9%). Il vandetanib aumenta significativamente la PFS rispetto al placebo ma con una tossicità importante: circa il 12% dei pazienti interrompe il trattamento per tossicità.
Due studi di fase II hanno evidenziato l’attività del vandetanib nel carcinoma midollare della tiroide localmente avanzato o metastatico: è stata riportata una percentuale di risposte parziali dal 15 al 20%, e la stabilità della malattia da circa il 50% dei pazienti. Successivamente, in uno studio in doppio cieco di fase III, il vandetanib, alla dose di 300mg/die per os, è stato confrontato con il placebo. I pazienti sono stati randomizzati 2:1. L’endpoint primario dello studio era la PFS49. Sono stati arruolati 331 pazienti con carcinoma midollare della tiroide localmente avanzato o metastatico. Dopo 24 mesi di follow-up, la PFS era significativamente aumentata con il vandetanib rispetto al placebo (mediana stimata 30,5 mesi vs. 19,3 mesi). Anche la percentuale di risposte era significativamente a favore del vandetanib (45% vs. 13%). Il farmaco si è rivelato tossico, in particolare i pazienti trattati con vandetanib riferivano una maggiore incidenza di diarrea (56% vs. 26%), nausea (33% vs. 16%), ipertensione (32% vs. 5%) e cefalea (26% vs. 9%). Il vandetanib aumenta significativamente la PFS rispetto al placebo ma con una tossicità importante: circa il 12% dei pazienti interrompe il trattamento per tossicità.
b) Cabozantinib
Il cabozantinib inibisce 3 pathways del carcinoma midollare della tiroide: il MET, il VEGFR2 e il RET. In uno studio di fase I il farmaco ha dimostrato di essere attivo in queste neoplasie; pertanto è stato eseguito uno studio randomizzato 2:1, doppio cieco, del cabozantinib versus placebo50. L’endpoint primario era la PFS. Il farmaco è stato usato a dosi di 140mg/die per os. La PFS era aumentata da 4,0 mesi con placebo a 11,2 mesi con cabozantinib (riduzione dell’HR del 72%). La percentuale di risposte era 28% vs. 0%. Gli effetti collaterali più frequenti del farmaco erano diarrea, eritrodisestesia palmo - plantare, diminuzione del peso e dell’appetito, nausea e fatigue. Il 16% dei pazienti trattati sospendeva la terapia per tossicità. Sia il vandetanib che il cabozantinib sono più attivi del placebo, ma non abbiamo ancora disponibile l’impatto sulla sopravvivenza dei due farmaci e purtroppo non è stata eseguita una valutazione della qualità di vita che ci avrebbe permesso di valutare meglio l’indice terapeutico dei due farmaci considerando anche la non scarsa tossicità. Al momento non è stato pubblicato alcuno studio di confronto tra i due farmaci.
Tumore stromale gastrointestinale metastatico
Finora i pazienti resistenti all’imatinib e al sunitinib non avevano alternative terapeutiche. Recentemente uno studio di fase II aveva mostrato che il regorafenib, farmaco che inibisce i recettori del KIT e del PDGF, coinvolti nell’induzione di resistenza del GIST, determina una percentuale di risposte + stabilità di malattia in circa il 79% dei pazienti. Ciò ha indotto ad eseguire uno studio randomizzato (2:1) doppio cieco di confronto tra regorafenib (160mg/die per os per 3 settimane, cicli ogni 4 settimane) e placebo. L’endpoint primario era la PFS51. Il regorafenib aumentava significativamente la PFS da 0,9 mesi a 4,8 mesi, con una diminuzione dell’HR del 73%. La percentuale di risposte + stabilità di malattia era del 75,9% vs. 34,8%. Dato che l’84% dei pazienti sottoposti a placebo, alla progressione di malattia sceglieva di passare a regorafenib, non si evidenziava una differenza nella OS fra i due gruppi di pazienti. Lo studio non valutava la qualità di vita dei pazienti. Il farmaco determinava più frequentemente ipertensione, sindrome mani-piedi e diarrea.
Carcinoma basocellulare localmente avanzato o metastatico
 Il carcinoma basocellulare è un tumore per la maggior parte dei casi guaribile. Un’alterazione del segnale hedgehog è implicata nella patogenesi del carcinoma basocellulare. Fino a poco tempo fa, non vi erano terapie valide nei casi in cui il tumore non era operabile o irradiabile. Recentemente uno studio di fase I ha evidenziato che il vismodegib, un inibitore del pathway hedgehog, è capace di indurre il 58% di risposte. Un successivo studio di fase II non randomizzato ha valutato due coorti di pazienti: metastatici e localmente avanzati52. Il vismodegib veniva somministrato a dosi di 150mg/die. L’endpoint primario era la percentuale di risposte obiettive. Nei 33 pazienti con malattia metastatica si otteneva un 30% di risposte, mentre nei 63 pazienti con carcinoma basocellulare localmente avanzato la percentuale di risposte era del 43%. In ambedue le coorti la durata della risposta era di 7,6 mesi. Gli eventi avversi, presenti in più del 30% dei pazienti trattati, erano spasmi muscolari, alopecia, disgeusia, perdita di peso e fatigue. Fra gli eventi avversi maggiori sono state riscontrate 7 morti per tossicità. In conclusione il vismodegib è il primo farmaco realmente attivo utilizzato nel carcinoma basocellulare. Il farmaco presenta una tossicità rilevante e non si hanno al momento evidenze circa il suo impatto sulla OS e sulla qualità di vita di tali pazienti.
Il carcinoma basocellulare è un tumore per la maggior parte dei casi guaribile. Un’alterazione del segnale hedgehog è implicata nella patogenesi del carcinoma basocellulare. Fino a poco tempo fa, non vi erano terapie valide nei casi in cui il tumore non era operabile o irradiabile. Recentemente uno studio di fase I ha evidenziato che il vismodegib, un inibitore del pathway hedgehog, è capace di indurre il 58% di risposte. Un successivo studio di fase II non randomizzato ha valutato due coorti di pazienti: metastatici e localmente avanzati52. Il vismodegib veniva somministrato a dosi di 150mg/die. L’endpoint primario era la percentuale di risposte obiettive. Nei 33 pazienti con malattia metastatica si otteneva un 30% di risposte, mentre nei 63 pazienti con carcinoma basocellulare localmente avanzato la percentuale di risposte era del 43%. In ambedue le coorti la durata della risposta era di 7,6 mesi. Gli eventi avversi, presenti in più del 30% dei pazienti trattati, erano spasmi muscolari, alopecia, disgeusia, perdita di peso e fatigue. Fra gli eventi avversi maggiori sono state riscontrate 7 morti per tossicità. In conclusione il vismodegib è il primo farmaco realmente attivo utilizzato nel carcinoma basocellulare. Il farmaco presenta una tossicità rilevante e non si hanno al momento evidenze circa il suo impatto sulla OS e sulla qualità di vita di tali pazienti.
Conclusioni
In questa revisione critica della letteratura inerente i risultati degli studi che hanno portato alla registrazione negli ultimi due anni dei farmaci antitumorali è stata posta l’attenzione specialmente ai farmaci a bersaglio molecolare ad eccezione dell’abraxane nel carcinoma metastatico del pancreas e dell’abiraterone e dell’enzalutamide nel carcinoma della prostata metastatico. Da un’analisi dettagliata di questi studi emerge un quadro di insieme abbastanza soddisfacente; infatti, con relativamente poche eccezioni, le autorizzazioni avute negli ultimi due anni sono da riferire a studi in gran parte di buona qualità. Ovviamente non va trascurato il fatto che rimangono criticismi legati ad un uso scriteriato delle analisi per sottogruppi come elemento di autorizzazione di un farmaco al commercio (vedi la saga dei RAS) o ad approvazioni basate su endpoint surrogati (PFS) senza che si accompagnino ad un beneficio del farmaco sulla OS e sulla qualità di vita o sui sintomi del paziente (bevacizumab nel carcinoma dell’ovaio). Infine va segnalato che spesso le autorità regolatorie approvano nuovi farmaci con miglioramenti della PFS o della OS statisticamente significativi ma clinicamente poco rilevanti (aflibercept e regorefenib nel colon-retto). Sotto un profilo metodologico, due sono i principali punti di criticità degli studi che hanno portato alla registrazione dei nuovi farmaci: l’uso, quasi a tappeto, della PFS come endpoint primario e la scelta del comparator, molto spesso il placebo. Per quanto concerne la PFS, non si capisce quale endpoint finale surroghi, se la OS o la qualità di vita. Nelle intenzioni dell’industria, che lo adotta con assiduità, probabilmente va riferito alla OS, ma appellandosi a motivazioni etiche, a nostro avviso, non facilmente sostenibili, la maggior parte degli studi, consentendo il crossover dei pazienti del gruppo di controllo al nuovo trattamento, impediscono di valutarne la reale efficacia, lasciando in ombra elementi essenziali per la definizione del suo reale valore in termini di prolungamento della sopravvivenza. La scelta del placebo come comparator assicura una valutazione di efficacia “assoluta” del nuovo farmaco, ma spesso traduce i risultati dello studio clinico in informazioni scarsamente utili nella pratica clinica, quando esistono già evidenze di efficacia della terapia standard. Colpisce la scarsità degli studi testa-a-testa, cioè di confronto fra trattamenti utili in pazienti omogenei, lasciando nell’indecisione i clinici che, invece, dovrebbero conoscere il valore di un nuovo farmaco relativamente alla terapia standard (spesso un nuovo farmaco precedentemente approvato). A nostro avviso, diversi punti della metodologia seguita dalle autorità regolatorie per l’approvazione dei nuovi farmaci dovrebbero essere rivisti. Tra questi, il più urgente sembra quello di stabilire di non procedere all’approvazione di un nuovo farmaco che sia sperimentato versus placebo quando, per quelle indicazioni, esista già almeno un trattamento di provata efficacia. Infine, si sarà osservato che in diversi casi il vantaggio che si ottiene con il nuovo farmaco è esiguo, e per di più in termini di endpoint surrogato. È quindi lecito ogni dubbio sulla sua reale efficacia in condizioni di pratica clinica, anche tenendo conto del contesto “astratto” in cui opera la ricerca (criteri di eleggibilità e di esclusione, diagnostica intensificata, follow up ravvicinati, e così via). Ciò apre immense possibilità di sviluppo alla ricerca sugli esiti (Outcome Research, OR), condotta indipendentemente dall’industria, su farmaci già approvati. L’OR non solo potrebbe verificare la riproducibilità o meno dei risultati della ricerca in condizioni di pratica clinica, ma consentirebbe anche di allargare l’orizzonte temporale degli eventi fino ad includere la valutazione della sopravvivenza globale nei casi in cui il lasso di tempo tra progressione di malattia e morte fosse piuttosto lungo. Inoltre, potrebbe fornire realistiche valutazioni dei costi, in quanto eseguite sul paziente che viene trattato nella pratica clinica quotidiana, come anche valutazioni di qualità di vita non frequentemente condotte negli studi sponsorizzati. I fondi ci sono: sarebbe sufficiente attingere alla quota che ciascuna ASL trattiene sui compensi per gli studi clinici sponsorizzati (anzi, questa sarebbe la loro destinazione naturale prevista dalla legge). Oggi si fa poca OR, per una pluralità di motivi, esterni ed interni al servizio sanitario nazionale. Tra i primi, va segnalata un’eccessiva burocratizzazione; tra i secondi, un’insufficiente sensibilizzazione dei vertici della sanità pubblica verso la ricerca clinica e le potenzialità dei suoi risultati, anzitutto a vantaggio del paziente, ma anche in termini di risparmio per la spesa sanitaria. Si fa tanto poca ricerca sugli esiti, eppure, a nostro avviso, è il futuro della Medicina.
L’OR non solo potrebbe verificare la riproducibilità o meno dei risultati della ricerca in condizioni di pratica clinica, ma consentirebbe anche di allargare l’orizzonte temporale degli eventi fino ad includere la valutazione della sopravvivenza globale nei casi in cui il lasso di tempo tra progressione di malattia e morte fosse piuttosto lungo. Inoltre, potrebbe fornire realistiche valutazioni dei costi, in quanto eseguite sul paziente che viene trattato nella pratica clinica quotidiana, come anche valutazioni di qualità di vita non frequentemente condotte negli studi sponsorizzati. I fondi ci sono: sarebbe sufficiente attingere alla quota che ciascuna ASL trattiene sui compensi per gli studi clinici sponsorizzati (anzi, questa sarebbe la loro destinazione naturale prevista dalla legge). Oggi si fa poca OR, per una pluralità di motivi, esterni ed interni al servizio sanitario nazionale. Tra i primi, va segnalata un’eccessiva burocratizzazione; tra i secondi, un’insufficiente sensibilizzazione dei vertici della sanità pubblica verso la ricerca clinica e le potenzialità dei suoi risultati, anzitutto a vantaggio del paziente, ma anche in termini di risparmio per la spesa sanitaria. Si fa tanto poca ricerca sugli esiti, eppure, a nostro avviso, è il futuro della Medicina.
1. Roila F, Ballatori E. Risultati delle analisi per sottogruppi ed autorizzazioni dei farmaci. Ars et Scientia, anno 2009, numero 1.
2. Van Cutsem E, Kohne CH, Lang I, et al. Cetuximab plus irinotecan, fluoruracil, and leucovorin as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: updated analysis of overall survival according to tumor KRAS and BRAF mutation status. J Clin Oncol 2011; 29:2011-2019.
3. Karapetis CS, Khambata - Ford S, Jonker DJ, et al. K-RAS mutations and benefit from cetuximab in advanced colorectal cancer. N Engl J Med 2008; 359:1757-1765.
4. Maughan TS, Adams R, Smith CG, et al. Addition of cetuximab to oxaliplatin-based first-line combination chemotherapy for treatment of advanced colorectal cancer: results of the randomised phase 3 MRC COIN trial. Lancet 2011; 377: 2103-2114.
5. Tweit KM, Guren T, Glimelius B, et al. Phase III trial of cetuximab with continuous or intermittent fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (Nordic FLOX) versus FLOX alone in first-line treatment of metastatic colorectal cancer: the NORDIC-VII study. J Clin Oncol 2012; 30:1755-1762.
6. Woo J, Palmisiano N, Tester W, et al. Controversies in antiepidermal growth factor receptor therapy in metastatic colorectal cancer. Cancer 2013; 119:1941-50.
7. Douillard J-Y, Siena S, Cassidy J, et al. Randomized phase III trial of panitumumab with infusional fluoruracil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer: the PRIME study. J Clin Oncol 2010; 28:4697-4705.
8. Douillard J-Y, Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab - FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013; 369:1023-1034.
9. Bokemeyer C, Bondarenko I, Hartmann JT, et al. Efficacy according to biomarker status of cetuximab plus FOLFOX4 as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: the OPUS study. Ann Oncol 2011; 22:1535-1546.
10. Bennet N. Anti-EGFR treatment and RAS - family mutations. Lancet Oncol 2013; September 20, http//dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70432-7.
11. Heinemann V, et al. Randomized comparison of FOLFIRI plus cetuximab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment of KRAS wild type metastatic colorectal cancer: German AIO study KRK-0306 (FIRE-3). J Clin Oncol 2013; 31:206s, abstract LBA3506.
12. Stintzing S, Jung A, Rossius L, et al. Analysis of KRAS/NRAS and BRAF mutations in FIRE-3: a randomized phase III study of FOLFIRI plus cetuximab or bevacizumab as first - line treatment for wild-type KRAS (exon 2) metastatic colorectal cancer. Eur J Cancer 2013; 49(Suppl. 3): s8, abstr. LBA17.
13. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of aflibercept to fluorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012; 30:3499-3506.
14. Bennouna J, Sastre J, Arnold D, et al. Continuation of bevacizumab after first progression in metastatic colorectal cancer (ML18147): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2013; 14:29-37.
15. Grothey A, Van Cutsem E, Sobrero A, et al. Regorafenib monotherapy for previously treated metastatic colorectal cancer (CORRECT): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013; 381:303-312.
16. Von Hoff DD, Ervin T, Francis P, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med 2013; 369:1691-1703.
17. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011; 364:1817-25.
18. Baselga J, Campone M, Piccart M, et al. Everolimus in postmenopausal hormone - receptor - positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012; 366:520-529.
19. Baselga J, Cortes J, Kim S-B, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2012; 366:109-119.
20. Swain MS, Kim S-B, Cortés J et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2 - positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013; 14:461-71.
21. Verma S, Miles D, Gianni L, et al. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012; 367:1783-1791.
22. De Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et al. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2011; 364:1995-2005.
23. Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS, et al. Abiraterone in metastatic prostate cancer without previous chemotherapy. N Engl J Med 2013; 368:138-148.
24. Scher HI, Fizazi K, Saad F, et al. Increased survival with enzalutamide in prostate after chemotherapy. N Engl J Med 2012; 367:1187-1197.
25. Chapman PB, Hauschild A, Robert C, et al. Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med 2011; 364:2507-16.
26. Chapman PB, et al. Update overall survival results for BRIM-3, a phase III randomized, open-label, multicenter trial comparing BRAF inhibitor vemurafenib with dacarbazine in previously untreated patients with BRAF V600E-mutated melanoma. J Clin Oncol 2012; 30:abstract 8502.
27. Hauschild A, Grob JJ, Demidov LV, et al. Dabrafenib in BRAF - mutated metastatic melanoma: a muticentre, open-label, phase 3 randomized controlled trial. Lancet 2012; 380:358-365.
28. Flaherty KT, Robert C, Hersey P, et al. Improved survival with MEK inhibition in BRAF - mutated melanoma. N Engl J Med 2012; 367: 107-114.
29. Flaherty KT, Infante GR, Daud A, et al. Combined BRAF and MEK inhibition in melanoma with BRAF V600 mutation. N Engl J Med 2012; 367:1694-703.
30. Hodi FS, O’ Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med 2010; 363:711-23.
31. Robert C, Thomas L, Bondarenko J, et al. Ipilimumab plus dacarbazine for previously untreated metastatic melanoma. N Engl J Med 2011; 364:2517-26.
32. Gilbert MR, Dignam JJ, Armstrong TS, et al. A randomized trial of bevacizumab for newly diagnosed glioblastoma. N Engl J Med 2014; 370:699-708.
33. Chinot OL, Wick W, Mason W, et al. Bevacizumab plus radiotherapy-temozolomide for newly diagnosed glioblastoma. N Engl J Med 2014; 370:709-722.
34. Sequist LV, Jang JC-H, Yamamoto N, et al. Phase III study of afatinib or cisplatin plus pemetrexed in patients with metastatic lung adenocarcinoma with EGFR mutation. J Clin Oncol 2013; 31:3327-3334.
35. Yang JC-H, Hirsh V, Schuler M, et al. Symptom control and quality of life in LUX-lung 3: a phase III study of afatinib or cisplatin/pemetrexed in patients with advanced lung adenocarcinoma with EGFR mutations. J Clin Oncol 2013; 31:3342-3350.
36. Wu Y-L, Zhou C, Hu C-P, et al. Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-lung 6): an open label, randomized phase 3 trial. Lancet Oncol 2014; 15:213-222.
37. Shaw AT, Kim D-W, Nakagawa K, et al. Crizotinib versus chemotherapy in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med 2013; 368:2385-94.
38. Rini BI, Escudier B, Tornczak P, et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cancer carcinoma (AXIS): a randomized phase 3 trial. Lancet 2011; 378:1931-39.
39. Motzer RJ, Escudier B, Tornczak P, et al. Axitinib versus sorafenib as second - line treatment for advanced renal cell carcinoma: overall survival analysis and updated results from a randomized phase 3 trial. Lancet Oncol 2013; 14:552-562.
40. Hutson TE, Lesovay V, Al-Shukri S, et al. Axitinib versus sorafenib as first-line therapy in patients with metastatic renal-cell carcinoma: a randomised open-label phase 3 trial. Lancet Oncol 2013; 14:1287-94.
41. Burger RA, Brady MF, Bookman MA, et al. Incorporation of bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer. N Engl J Med 2011; 365:2473-2481.
42. Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, et al. A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. N Engl J Med 2011; 365:2484-96.
43. Stark D, Nankivell M, Pujade - Lauraine E, et al. Standard chemotherapy with or without bevacizumab in advanced ovarian cancer: quality-of-life outcomes from the international collaboration on ovarian neoplasms (ICON7) phase 3 randomised trial. Lancet Oncol 2013; 14:236-243.
44. Bast RC, Thigpen JT, Arbuck SG et al. Clinical trial endpoints in ovarian cancer: report of an FDA/ASCO/AACR Public Workshop. Gynecol Oncol 2007; 107:173-176.
45. Broglio KR, Berry DA. Detecting an overall survival benefit that is derived from progression-free survival. J Natl Cancer Inst 2009; 101:1642-1649.
46. Amir E, Seruga B, Kwong R, et al. Poor correlation between progression - free survival and overall survival in modern clinical trials: are composite endpoints the answer? Eur J Cancer 2012; 48:385-388.
47. Metha DA, Hay JW. Cost-effectiveness of adding bevacizumab to first line therapy for patients with advanced ovarian cancer. Gynecol Oncol 2014; Jan 23. pii: S0090-8258 (14)00037-7. doi: 10.1016/j.ygyno.2014.01.021.
48. Dyer M, Richardson J, Robertson J, et al. NICE guidance on bevacizumab in combination with paclitaxel and carboplatin for the first-line treatment of advanced ovarian cancer. Lancet Oncol 2013; 14:689-90.
49. Wells Jr SA, Robinson BG, Gagel RF, et al. Vandetanib in patients with locally advanced or metastatic medullary thyroid cancer: a randomized, double - blind phase III trial. J Clin Oncol 2011; 30:134-141.
50. Elisei R, Schlumberger MJ, Muller SP, et al. Cabozantinib in progressive medullary thyroid cancer. J Clin Oncol 2013; 31:3639-3646.
51. Demetri GD, Reichardt P, Kang Y-K, et al. Efficacy and safety of regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib: an international, multicentre, prospective, randomised, placebo-controlled phase 3 trial (GRID). Lancet 2013; 381:295-302.
52. Sekulic A, Migden MR, Oro AE, et al. Efficacy and safety of vismodegib in advanced basal-cell carcinoma. N Engl J Med 2012; 366: 2171-2179.
Data di Redazione 06/2014
La reiterazione di un test statistico sullo stesso materiale sperimentale altera automaticamente il livello di significatività. Ad esempio, fissare il livello di significatività al 5%, vuol dire che, se l’ipotesi nulla di uguale efficacia di due trattamenti è vera, c’è il 5% di probabilità di sbagliare nel respingerla, ma c’è anche il 95% di probabilità di accettarla.
Supponiamo ora di confrontare la risposta a due trattamenti nei pazienti con KRAS wild type e nei pazienti con KRAS mutato. Il test viene dunque replicato due volte, una per ciascun sottocollettivo. Poiché i pazienti sono diversi, i due test vengono eseguiti indipendentemente uno dall’altro. Pertanto, se i trattamenti avessero la stessa efficacia, la probabilità di accettare sempre l’ipotesi nulla sarebbe pari a 0,95x0,95=0,9025. Quindi, la probabilità di respingere l’ipotesi nulla almeno una volta (sbagliando) è pari a 1-0,9025=0,0975, quasi il doppio del 5% fissato convenzionalmente. Occorre quindi modificare il livello di significatività per ciascun confronto in modo che sia pari al 5% il livello di significatività complessivo. Tale modifica consiste, approssimativamente, nel dividere il livello di significatività per il numero dei confronti eseguiti.
Nel nostro esempio, il livello di significatività con cui fare i conti nell’eseguire il test in ciascun sottocollettivo è dunque pari a circa il 2,5%, affinché il livello di significatività complessivo sia del 5%. La situazione diventa intrattabile, nel senso che fornisce risultati difficilmente significativi, quando i confronti fra i trattamenti sono ripetuti più volte, come ad esempio nel nostro caso quando il test è stato eseguito più volte all’accumularsi nel tempo delle determinazioni dello stato del KRAS. Ad esempio, se le analisi fossero state condotte 5 volte, ciascuna per i due sottocollettivi, si sarebbero eseguiti 10 test statistici, portando così il livello di significatività di ciascuno di essi a circa lo 0,005 (5 per mille), per conservare il livello di significatività complessivo al 5%: in tale situazione, a meno che non ci siano grandi differenze di efficacia, nessun confronto risulterà mai significativo (v. Statistica per concetti, CASCO 2011; 1:26-27).
Endpoint surrogati.
A parte la qualità di vita, l’unico endpoint di efficacia di una terapia è la Sopravvivenza Globale (OS). Si possono accettare endpoint intermedi (o surrogati), come ad esempio la PFS, solo dopo aver dimostrato che siano realmente variabili proxy dell’endpoint finale (OS), cioè che esista una relazione (quasi) causale che lega la PFS alla OS. Ma questa relazione dovrebbe essere dimostrata per ogni tipo di tumore e per ogni trattamento, in quanto, ad esempio, potrebbe verificarsi che per il cancro del colon il legame associativo sia forte, mentre sia debole per il cancro del polmone, ovvero che nel cancro del colon sia forte con l’associazione acido folinico e fluorouracile ma non con irinotecan+cetuximab. Questo non è stato fatto. In altre parole, potrebbe accadere che il tempo che trascorre dalla ripresa della malattia alla morte (T) non sia lo stesso per i pazienti che hanno avuto una PFS “breve” o una PFS “lunga”; se questi ultimi avessero un valore di T assai più breve, l’ipotesi si rivelerebbe falsa. Inoltre, la data di morte è certa, mentre non altrettanto lo è quella della PFS. In quest’ultimo caso, infatti, ci si può accorgere della progressione della malattia o nel corso di una visita di follow up (che non sempre avviene ai tempi prestabiliti, e, comunque, in qualche circostanza può essere ritardata dalle cattive condizioni del paziente), o in seguito alla presenza di una nuova sintomatologia che induca il paziente a recarsi dal medico per chiarire le cause delle sue mutate condizioni; in questo secondo caso è evidente come un paziente possa precipitarsi dal medico all’insorgere della sintomatologia, mentre un altro potrebbe richiedere una visita dopo qualche tempo in cui ha sperato che i sintomi cessassero spontaneamente. In conclusione, senza evidenze di una relazione di causalità, non è lecito avvalersi di endpoint surrogati.
Nemmeno una forte correlazione tra PFS e OS sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità: occorrerebbero studi ad hoc ed attente riflessioni. Allora perché è stata scelta la PFS anziché la OS come endpoint primario? Anzitutto perché nelle neoplasie del colon - retto la OS è mediamente lunga e ciò richiederebbe un eccessivo protrarsi dello studio. In secondo luogo perché così si tenta di evitare l’influenza delle successive linee di terapia sulla OS, in assenza di un comportamento uniforme degli oncologi nella loro scelta. Quest’ultima considerazione ci sembra però difficile da accettare, proprio in quanto, per il principio di randomizzazione, il paziente è assegnato al trattamento con tutte le sue caratteristiche, tra cui anche i trattamenti futuri che risulterebbero pertanto bilanciati tra i due gruppi (v. CASCO, Statistica per concetti 2011, 2:60-61; 2013, 7:25-27).
Ad una ulteriore riflessione, quando la sola PFS, ma non la OS, è significativamente a favore del nuovo farmaco, non si può logicamente ricorrere alla motivazione che siano state le successive linee di terapia a produrre una tale differenza di comportamento perché, in tal caso verrebbe da chiedersi se il farmaco sperimentale sia veramente utile dato che, con le sole linee successive di terapia si ottiene una sopravvivenza paragonabile tra i due trattamenti.
Il crossover del trattamento.
Una volta provato l’effetto positivo del trattamento sulla PFS, a prima vista sembra etico consentire al paziente del gruppo di controllo di passare al trattamento ritenuto più efficace. Così operando, però, si perde l’informazione più importante, cioè quella sull’efficacia del trattamento, ossia sul suo effetto sulla sopravvivenza globale (OS).
ll crossover andrebbe evitato o al più limitato (e non sempre) alle neoplasie in cui il tempo tra la progressione della malattia e la morte è così lungo da far sorgere il dubbio che sarebbe non etico impedire al paziente arruolato di avvalersi del trattamento che sembra essere più efficace, a patto però che sia già stata dimostrata la relazione (quasi) causale tra l’endpoint intermedio (ad es., la PFS) e quello finale (OS).
Infatti, se la OS è all’incirca la stessa tra i due gruppi sperimentali, ma la PFS è favorevole al nuovo trattamento, una non significativamente diversa OS potrebbe essere dovuta o ai trattamenti successivi alla progressione (incluso il nuovo trattamento cui ha scelto di sottoporsi il paziente del gruppo di controllo) o ad un mediamente inferiore lasso di tempo tra progressione e morte nei pazienti che hanno avuto una PFS più lunga con il nuovo trattamento.
La scelta di PFS e OS come endpoint co-primari, consentendo il crossover, in realtà nasconde la scelta della PFS come solo endpoint principale. L’unica procedura che coniuga le istanze etiche e quelle scientifiche è consentire il crossover, ma solo dopo aver dimostrato l’efficacia del nuovo trattamento in termini di OS. In conclusione, a meno di ponderate e giuste ragioni, il crossover è da evitare perché la mancata certezza dell’efficacia di un nuovo farmaco si traduce nella necessità di replicare lo studio, rendendo tutta la procedura assai meno etica di quella adottata consentendo il crossover. Data anche l’incertezza della valutazione della PFS, potrebbe addirittura venire il dubbio che la possibilità del crossover sia una procedura introdotta per celare la scarsa efficacia del nuovo farmaco in termini di prolungamento della sopravvivenza.
Il costo del trattamento.
Nel recente passato, le sperimentazioni cliniche di fase III erano spesso accompagnate da una parallela valutazione economica differenziale dei trattamenti. Purtroppo, questa buona abitudine è andata persa, preferendo l’industria seguire la via della costruzione di modelli farmacoeconomici dopo la pubblicazione dei risultati di efficacia/tollerabilità. In ogni caso occorre tener presente che, prima di procedere alla valutazione dei costi, è necessario definire la prospettiva da cui eseguire la valutazione (prospettiva dell’ospedale, del paziente e della sua famiglia, del SSN, dell’intera società) perché un costo valutato da una certa prospettiva, da un’altra prospettiva può essere diverso o addirittura non essere affatto un costo. In secondo luogo, la valutazione dei costi va eseguita nell’ottica della massima globalità, considerando cioè tutti i costi e non solo quelli di acquisizione del farmaco.
In particolare, i costi sostenuti per il management degli eventi avversi in certi casi sono assai rilevanti, come, ad es., quando la cura dell’evento avverso richieda giornate aggiuntive di degenza. Valutati i costi complessivi dei trattamenti nei due bracci, si calcola facilmente il costo medio per paziente. Il più importante indicatore del costo del trattamento A (ad es., nuova terapia) in confronto a B (trattamento standard) è il costo incrementale (CI), costruito come rapporto tra la differenza dei costi medi per paziente nei due bracci, C(A)-C(B), e la differenza di efficacia, E(A)-E(B):CI = [C(A)-C(B)] / [E(A)-E(B)]. Il costo incrementale misura qual è il costo aggiuntivo del nuovo trattamento per ottenere un’unità di efficacia in più.
Ad esempio, consideriamo l’afatinib ed ipotizziamo che il costo medio per paziente, valutato nell’ottica della massima globalità, sia 20.000 euro, mentre sia 8.000 euro quello del cisplatino+gemcitabina. Considerando la PFS, che passa da 5,6 a 11 mesi, il costo incrementale è CI=12.000/5,4=2.222: ottenere un mese in più di PFS con afatinib rispetto a cisplatino + gemcitabina costa, in media, 2.222 euro.
La differenza minima clinicamente rilevante.
È un parametro particolarmente delicato nel calcolo della dimensione campionaria per la inevitabile componente di soggettività. A parità delle altre condizioni (tipo di test statistico, livello di significatività e potenza), è necessaria una numerosità di pazienti tanto più grande quanto più piccola si fissa la differenza minima clinicamente rilevante. La scelta del test, il livello di significatività e la potenza dello studio, con poche varianti, sono ormai standard internazionali, ma concorrono tante ragioni, le più disparate, a definire la differenza minima clinicamente rilevante. Se l’ultimo studio descritto fosse stato a due bracci (escludendo il terzo), con bevacizumab si sarebbe evidenziata una riduzione del rischio di progressione del 10%, mentre la differenza minima clinicamente rilevante era considerata del 23%.
Quindi, che valore ha una differenza, pur statisticamente significativa, ma così lontana da quella differenza minima clinicamente rilevante fissata al momento della programmazione dello studio? La risposta è: dipende. Anzitutto occorre tener presente che il risultato dello studio è una stima (puntuale) di un parametro e, pertanto, occorrerebbe comunque calcolare un intervallo di confidenza intorno a tale stima per vedere se comprende la differenza minima clinicamente rilevante. In caso affermativo, il risultato è in linea con le attese. In caso negativo occorre esplorare altre ragioni per cui ciò possa essere avvenuto.
Ad esempio, la differenza minima clinicamente rilevante potrebbe essere stata fissata troppo alta semplicemente perché non c’erano risorse sufficienti per arruolare un elevatissimo numero di pazienti. In tal caso il suo significato è improprio, cioè irrilevante, ma si corre il serio rischio di ottenere risultati negativi quando, invece, il nuovo farmaco ha una sua efficacia. Viceversa, se la si fissa troppo bassa, la dimensione dello studio diventa esagerata per cui anche una lievissima maggior efficacia del nuovo trattamento risulta statisticamente significativa; in tal caso siamo di fronte alla ormai classica differenza “statisticamente significativa, ma clinicamente non rilevante”.